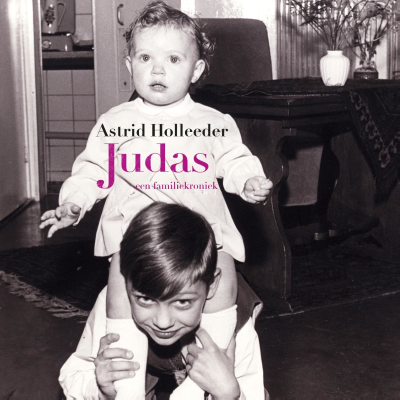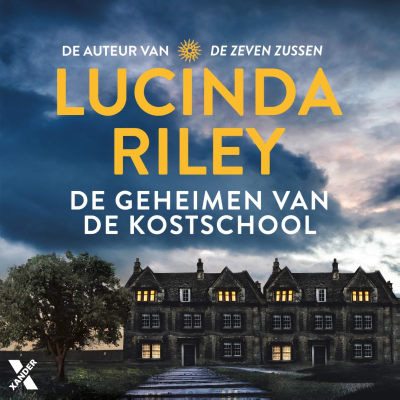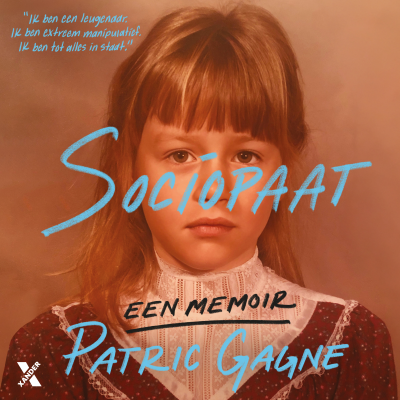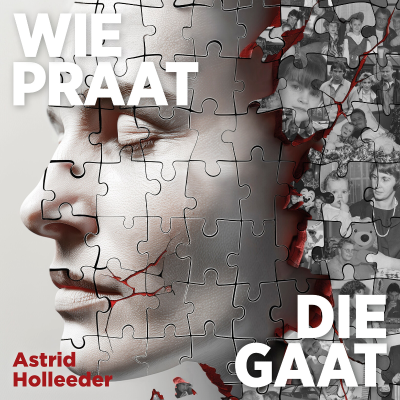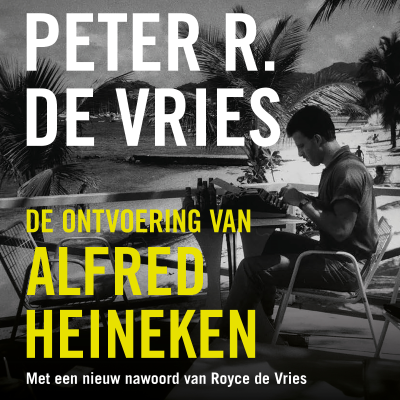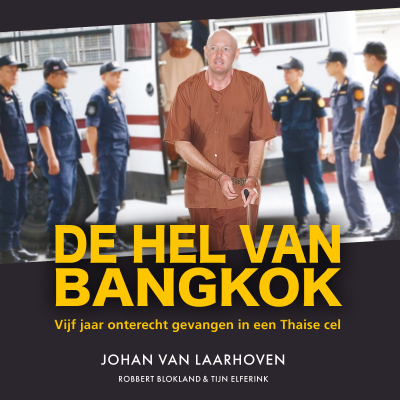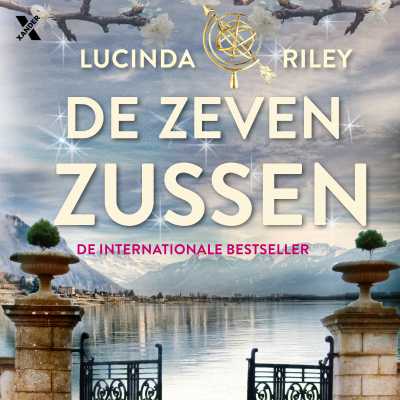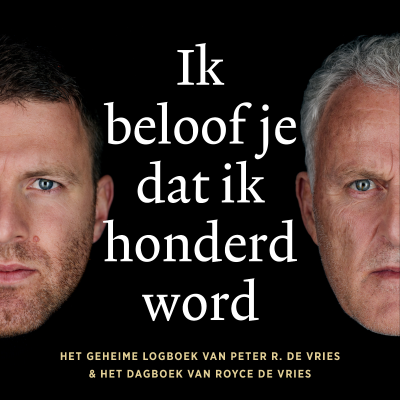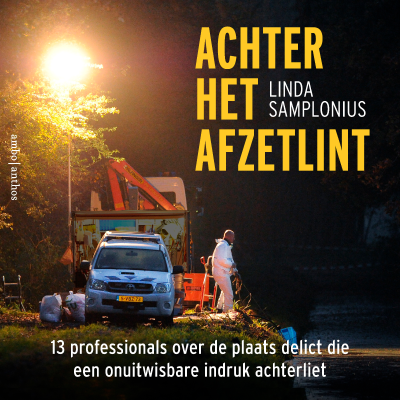Liber Liber
Podcast door Liber Liber
Libri, audiolibri e musica con licenze libere
Probeer 7 dagen gratis
€ 9,99 / maand na proefperiode.Elk moment opzegbaar.
Alle afleveringen
616 afleveringenGemma Ferruggia scrisse questo romanzo nel 1919, appena dopo la fine della prima guerra mondiale. L’autrice racconta una storia d’amore, e come si scoprirà nel corso della narrazione, adulterino, nella cornice storica del primo conflitto mondiale. La struttura del romanzo presenta delle particolarità, nel senso che la narrazione inizia con due capitoli, dal titolo eloquente, che sono come una sorta di preambolo di tutta la narrazione successiva, mentre la vicenda vera e propria si sviluppa nei successivi quattro capitoli. In questi due capitoli non viene svelata la vera identità dei due protagonisti, che si definiscono come “Anima” e “Cuore”. Si sa che il protagonista maschile, “Cuore”, era impegnato nel conflitto come ufficiale degli Arditi. E l’incipit preannuncia già quale sarà l’approccio e lo sviluppo della narrazione: “La stanza, in cui entro, con passo risoluto e leggero, un passo senza eco, non ha pareti. È nell’infinito.” Appena dopo l’autrice spiegherà il significato di questa frase. “Varcando la soglia — dove la fantasia ha posto l’Arcangelo dalla spada fiammeggiante — sono da qualche minuto entrata nello sconfinato orizzonte dell’anima mia.” Il romanzo gioca in tutto il suo svolgersi, sul binomio “Anima” e “Cuore”, come se fossero le due facce di una stessa medaglia. L’autrice dirà nel Commiato conclusivo che nella loro diversità i due protagonisti, senza rendersi conto di ciò, erano “Uno”. Il vero nome dei due protagonisti principali verrà svelato solo dopo questa sorta di preambolo. I due capitoli iniziali sono raccontati in prima persona dai due protagonisti principali. Il primo da “Anima”, cioè la protagonista femminile, che entrando nello sconfinato suo mondo, cioè nel suo io, racconta i suoi stati d’animo, anche rispetto alla guerra, che all’epoca della scrittura di questo romanzo era appena terminata. Il secondo capitolo è raccontato da “Cuore”, cioè il protagonista maschile, il quale ripercorre la sua attività militare con il pensiero costante alla sua amata. Queste poche parole, appena scritte, in merito ai due capitoli introduttivi sono ampiamente riduttive rispetto alle innumerevoli sfaccettature e sfumature espresse dalla scrittrice in queste due parti iniziali, sulla personalità di questi due personaggi. Dopo questa introduzione essenzialmente di carattere intimistico, i due protagonisti, – Chiara Alba e Uberto Insera, questi sono i loro veri nomi – terminato loro percorso interiore, che forma i primi due capitoli – entrando “nello sconfinato mondo dell’anima …” –, inizia la vicenda amorosa vera e propria dei due amanti. Questa si snoda dal loro viaggio in treno da Roma a Milano e il successivo soggiorno a Milano fino alla nemesi che si concreta con loro separazione finale. L’autrice dipinge non solo i due personaggi principali curando in particolare modo la loro personalità, ma anche il mondo nel quale vivono, e i vari personaggi di contorno che formano il loro mondo borghese. Non viene dimenticato dall’autrice di tratteggiare i vari aspetti politici di una società e di un mondo che stava cambiando, con vari riferimenti sia ad avvenimenti italiani – ad esempio le imprese dannunziane – che ad avvenimenti stranieri. Questa attenzione all’attualità, è presente in tutto lo sviluppo della narrazione. Non viene mai dimenticato dalla scrittrice di esprimere il suo giudizio, anche se non in modo palese, sulle varie problematiche sorte in seguito al primo conflitto mondiale. Questa opera di Gemma Feruggia, ad avviso di chi scrive, è molto aderente al modo di essere della scrittrice, nella sua adesione ad istanze nazionaliste, a partire dagli anni ’10, e nel suo femminismo sui generis. Cioè critico con i movimenti femministi dell’epoca, ma favorevole all’emancipazione femminile, pur vedendola come un percorso personale. Sinossi a cura di Piero Giuseppe Perduca Dall’incipit del libro: La stanza, in cui entro, con passo risoluto e leggero, un passo senza eco, non ha pareti. È nell’infinito. Talvolta buia come delitto senza scopo, sfolgorante talvolta della luce che immaginiamo componga il viso degli arcangeli. E precisamente il volto dell’arcangelo Michele quale io me lo figuro, illuminato di sole sanguigno nell’atto di dar battaglia. Il principe delle milizie celesti sta sulla soglia ideale a custodia del paradiso e dell’inferno che fan contrasto nel luogo singolarissimo: il come — ignoto alla mia terrena fragilità — è secreto della divina creatura. Un uomo non potrebbe. Una donna non oserebbe. Par quanto io sia volontaria e forte — mostruosamente forte per l’ipocrisia femminile, mantello di porpora e fummo come coppe colme di reciproco perdono. Veramente il mondo sovvertito ebbe riflessi nelle anime: mutò freddezze in ardori: egoismi in dedizioni generose: donò ali ai mediocri: cinse di aureola il capo degli umili. Non soltanto «Anima» e «Cuore» si sentirono congiunti alla sventura d’Italia come linfe dello stesso ricco albero. La quercia sacra — che non può essere recisa alla base — fu allora per tutti gli italiani meraviglia di novelle frasche, garrule di canti nuovi, verso un cielo da riconquistare: dai piedi alla cima l’aveva fiorita il sangue degli eroi. Scarica gratis: Il sole nascosto [https://liberliber.it/autori/autori-f/gemma-ferruggia/il-sole-nascosto/] di Gemma Ferruggia [https://liberliber.it/autori/autori-f/gemma-ferruggia/].
Liber Liber ricorda, a 100 anni dalla morte, la figura di Giacomo Matteotti (Fratta Polesine, 22 maggio 1885 – Roma, 10 giugno 1924), politico, giornalista e antifascista italiano, segretario del Partito Socialista Unitario, con un invito alla lettura. Grazie ai volontari del Progetto Manuzio sono ora online (disponibili per il download gratuito) le seguenti opere: * Reliquie [https://liberliber.it/autori/autori-m/giacomo-matteotti/reliquie/] di Giacomo Matteotti [https://liberliber.it/autori/autori-m/giacomo-matteotti/]. Pubblicato nel 1946, il libro raccoglie gli scritti di Giacomo Matteotti, oltre alla relazione stenografica del suo ultimo discorso alla Camera dei deputati, a una breve nota biografica ed al ricordo di Filippo Turati. * La difesa della libertà [https://liberliber.it/autori/autori-m/giacomo-matteotti/la-difesa-della-liberta/] di Giacomo Matteotti [https://liberliber.it/autori/autori-m/giacomo-matteotti/]. In questo opuscolo con il resoconto parlamentare dell’ultimo discorso di Matteotti alla Camera dei Deputati (30 maggio 1024), il deputato chiede alla Giunta delle elezioni di annullare il risultato elettorale: queste si sarebbero svolte in un forte clima di intimidazione e violenza. * L’assassinio di Giacomo Matteotti [https://liberliber.it/autori/autori-m/giuseppe-emanuele-modigliani/lassassinio-di-giacomo-matteotti/] di Giuseppe Emanuele Modigliani [https://liberliber.it/autori/autori-m/giuseppe-emanuele-modigliani/]. Modigliani si occupò dell’assassinio sia come compagno di partito ed amico di Matteotti, sia come avvocato della moglie, che si costituì parte civile nel processo che viene qui descritto. Questo opuscolo, pubblicato nel 1944, ripercorre con minuzia gli eventi. * La tragedia di Giacomo Matteotti [https://liberliber.it/autori/autori-t/filippo-turati/la-tragedia-di-giacomo-matteotti/] di Filippo Turati [https://liberliber.it/autori/autori-t/filippo-turati/] e Anna Kuliscioff [https://liberliber.it/autori/autori-k/anna-kuliscioff/]. Questo breve volume (1945) raccoglie la corrispondenza scambiata fra l’11 e il 27 giugno 1924 tra Filippo Turati, all’epoca parlamentare a Roma, e la sua compagna di vita e di lotte Anna Kuliscioff. L’epistolario è incentrato sulla scomparsa e l’omicidio di Matteotti, sulle reazioni private e quelle pubbliche, sulle posizioni delle Opposizioni e della maggioranza. * L’idolatra [https://liberliber.it/autori/autori-t/velia-titta-matteotti/lidolatra/] di Velia Titta Matteotti [https://liberliber.it/autori/autori-t/velia-titta-matteotti/]. L’autrice, moglie di Giacomo Matteotti, proveniva da una famiglia di artisti, il fratello fu un celebre baritono. Non stupisce quindi che Velia Titta, già moglie e madre, dedicasse il suo tempo libero alla letteratura, pubblicando nel 1920 questo romanzo, con uno pseudonimo maschile, Andrea Rota. Già pubblicati sullo stesso argomento: * Un anno di dominazione fascista [https://liberliber.it/autori/autori-m/giacomo-matteotti/un-anno-di-dominazione-fascista/] di Giacomo Matteotti [https://liberliber.it/autori/autori-m/giacomo-matteotti/] * Sul fascismo [https://liberliber.it/autori/autori-g/antonio-gramsci/sul-fascismo/] di Antonio Gramsci [https://liberliber.it/autori/autori-g/antonio-gramsci/] * Matteotti [https://liberliber.it/autori/autori-g/piero-gobetti/matteotti/] di Piero Gobetti [https://liberliber.it/autori/autori-g/piero-gobetti/]
Eugenio Giovannetti, traduttore e prefatore di questo testo, sceglie cinque racconti di Keller tratti da raccolte diverse e li offre al lettore italiano quasi come un assaggio delle qualità solide e poliedriche dell’autore. Non rispetta l’ordine cronologico e questo non è probabilmente un pregio. La novella che apre il volume e che dà il titolo alla raccolta è infatti stata scritta successivamente alle due che seguono. Romeo e Giulietta al Villaggio (Romeo und Julia auf dem Dorfe) e I tre giusti pettinai (Die drei gerechten Kammacher) sono comprese nel primo volume di La gente di Seldwyla (Die Leute von Seldwyla). Nel primo i protagonisti Sali Manz e Vrenchen (Veronichetta in questa traduzione) Marti sono figli di due agricoltori di un villaggio adiacente a Seldwyla. I due genitori sperperano ogni loro ricchezza nell’assurdo processo intentato per contendersi con ostinata reciproca ostilità la proprietà di un terreno attiguo ai loro poderi. Sali e Vrenchen, compagni di giochi fin da bambini, si incontrano nuovamente da giovani adolescenti con i genitori ormai in rovina e si innamorano. Ma vengono sorpresi in campagna dal padre di Vrenchen e Sali per difendere la ragazza dalle ire paterne colpisce l’anziano agricoltore che perde quindi memoria e ragione. Vrenchen per mantenersi dovrà andare lontano, a servizio, e Sali non ha i mezzi per sposarla. Decidono quindi di trascorrere una giornata a una festa di paese e al ballo come fossero due sposini. Il finale è forse tragico, ma pervaso da una dolcezza e un sentimento che lo fa apparire un lieto fine. I tre giusti pettinai sono tre giovani apprendisti del pettinaio di Seldwyla, di tre diverse nazionalità, zelanti e parsimoniosi. Ambiscono a rilevare l’azienda del padrone, che sul loro lavoro prospera ma con una vita dissipata si indebita, e a sposare la gretta zitella Züs (Susanna in questa traduzione) Bünzlin, agiata proprietaria di una piccola bottega. Quando il padrone, per ridurre le spese e in crisi di sovraproduzione, decide di licenziare due dei tre ragazzi li sottopone a una gara di corsa il vincente della quale rimarrà al lavoro (e sposerà la zitella). Mentre due di loro si accapigliano per prevalere, il terzo, lo svevo Dietrich (Teodorico), non parte neppure, seduce definitivamente Züs e con i soldi di lei compra la fabbrica dei pettini. Lettere d’amore perdute (Die missbrauchten Liebesbriefe) è tratto invece dal secondo volume di Die Leute von Seldwyla che, per quanto composto in gran parte nel periodo berlinese dell’autore, andò alle stampe a Stoccarda solo nel 1874, diciotto anni dopo il primo. Viggi Störteler è titolare di una prospera ditta di spedizioni ma ha anche velleità letterarie. Vorrebbe la collaborazione della moglie Gritli, brava e semplice casalinga, e le impone, durante un suo viaggio d’affari di scambiare con lui un carteggio amoroso. Gritli è in grave impaccio per assolvere il compito assegnatole dal marito e ricorre a un sentimentale maestrino segretamente suo spasimante. Invia le lettere del marito, appena ritoccate al maestrino e invia al marito, nuovamente ritoccandole un poco, le lettere che l’appassionato maestrino invia a lei. Ma al ritorno Viggi scopre per caso le proprie lettere nella borsa del maestrino, crede che Gritli lo abbia tradito e la caccia e divorzia. Il suo nuovo matrimonio con una donna brutta e avida lo condurrà alla rovina, mentre Gritli e il maestro, ormai maturato e divenuto saggio e responsabile, saranno felici. Queste prime tre novelle sono quindi ambientate nell’immaginaria cittadina di Selwyla, che l’autore presenta nelle brevi pagine d’introduzione. «Seldwyla in linguaggio arcaico significa una località piacevole e solatia, e tale è di fatto la cittadina di questo nome situata in qualche posto della Svizzera. È ancora circondata dalla stessa cerchia di mura e di torri antiche come trecento anni or sono, ed è pur sempre rimasta lo stesso paesino. […] Il nucleo e il vanto della popolazione consistono nei giovanotti dai venti ai trentacinque anni: sono essi che dànno il tono, che tengono viva la socievolezza e rappresentano il fasto di Seldwyla. Durante quel periodo giovanile esercitano il mestiere, la professione, l’abilità, quel che insomma hanno imparato, cioè fanno lavorare per loro, sin che possono, gente estranea, valendosi intanto della propria professione per un comodo giro di debiti che costituisce la base di ogni potere e magnificenza e letizia per i signori seldwylesi e che vien quindi tenuto in vita con raffinata reciprocanza e comprensione, ma, si noti bene, sempre soltanto fra questa aristocrazia giovanile.» La garbata ironia di Keller viene quindi preannunciata in maniera programmatica evidente da questo stralcio dell’introduzione che l’autore antepone alla sua raccolta di novelle. Il racconto che chiude questa raccolta – Eugenia (Eugenie) – è tratto invece da Sieben Legenden (Sette leggende) della quale raccolta è il racconto d’apertura. Anche l’ideazione di queste novelle risale al periodo berlinese anche se furono pubblicate la prima volta a Stoccarda nel 1872. Scrive l’autore come nota introduttiva a questa raccolta: «Avendo letto alcune leggende, parve all’autore di questo libretto che nel complesso di tali saghe si manifestasse non solo l’arte della favola religiosa, ma anche a guardar bene, la traccia di un’antica e più profana passione per il novellare. Ora, come un particolare di nubi, un profilo di montagne, un’incisione di un artista dimenticato spingono il pittore a riempire una cornice, così l’autore s’è sentito invogliato a ridar forma a quelle immagini frammentarie e fluttuanti; certo è avvenuto che talora esse volgano il viso verso un punto cardinale diverso da quello della loro posa tradizionale. Su questa vastissima materia ci si potrebbe diffondere con la massima ampiezza; ma il gioco innocente può, credo, acquistarsi il posticino a cui aspira, soltanto quando sia moderato.» Eugenia è una giovane bellissima e intelligentissima donna che per un capriccio rifiuta di sposare il proconsole romano Aquilino che pure ama. Si fa quindi cristiana e fingendosi maschio entra in un convento diventando in breve il priore dello stesso. Viene calunniata da una matrona che si era incapricciata dal “bel fraticello”. Per evitare la condanna di Aquilino che finge di non riconoscerla è costretta a lacerare il suo saio e scoprire la propria identità femminile. Convertirà poi Aquilino al cristianesimo e diverrà martire al momento delle persecuzioni dei cristiani. L’intercessione di questa martire cristiana sembra che valga per le scolare pigre rimaste indietro nello studio. Queste novelle avrebbero dovuto essere radunate, alternate ad altre di argomento profano, in una raccolta, che non vide mai la luce, dal titolo Galatea. Le novelle che avrebbero completato la raccolta apparvero poi, completamente riviste, nella raccolta L’Epigramma. I soggetti delle Sette Leggende – le leggende che l’autore dichiara di aver letto nella sua introduzione – sono quelle delle Legenden di Ludwik Theobul Kosegarten che erano state pubblicate nel 1816. Orsola (Ursula) – la quarta novella del testo che presentiamo – è la novella che chiude la raccolta di Novelle zurighesi (Züricher Novellen) ed era l’unica inedita – al momento della prima stampa del volume nel 1877 – delle cinque che sono comprese in questa raccolta. Le prime tre erano già state pubblicate sulla rivista “Deutsche Rundschau” tra novembre 1876 e aprile 1877, la quarta risale addirittura a 17 anni prima. Mentre i Seldwyler agivano ancora in un paesaggio svizzero immaginario, gli zurighesi vengono ora inseriti in uno sfondo storico. Orsola è ambientato nei primi decenni del XVI secolo, quando Hansli (Giovannino in questa traduzione) Gyr torna a casa dopo aver partecipato vittoriosamente con l’esercito zurighese alla difesa del papato dalle pretese francesi. Vorrebbe sposare Orsola secondo i riti e le usanze cattoliche ma si scontra con le usanze anabattiste e il loro fanatico millenarismo che avevano coinvolto la famiglia di Orsola stessa. La vicenda si interseca poi con la predicazione di Zwingli, del quale Hansli Gyr diviene seguace, ma non al punto da dimenticare Orsola. Quando Zwingli sconfigge gli anabattisti e li imprigiona, Gyr non esiterà a liberare Orsola, che nella sua follia millenarista crede che il suo liberatore sia l’arcangelo Gabriele. Ma sarà poi Orsola, ripresasi dalla confusione mentale, a trarre in salvo Hansli Gyr moribondo in seguito a una nuova vicenda bellica. Keller ebbe grande celebrità in Svizzera e ancora oggi è considerato il più importante letterato svizzero di lingua tedesca. Apprezzato da Nietzsche, fu oggetto di attenzione anche da parte di Walter Benjamin che gli dedicò un articolo sulla rivista “Literarische Welt” nel quale definisce Keller «quel maestro alla cui scuola tutti devono passare per lasciarsi avvolgere da una fiamma che custodisce un segreto: quello della vita» e ne esamina i meccanismi creativi dietro i quali si celano le sue qualità più notevoli. Ma il riconoscimento che si può dire consacri Keller all’interno dell’universalismo letterario venne nel 1936 da Georg Lukàcs che in un suo saggio parla entusiasticamente dell’autore svizzero: «Keller è grande perché nelle condizioni del suo tempo, sfavorevoli dal punto di vista politico sociale e artistico, ha creato nonostante tutto un’arte così alta, un’arte non ristrettamente provinciale»; «uno dei massimi scrittori epici del XIX secolo»; «è venuto il momento di considerare da questo punto di vista la carriera di Keller e di assegnargli il giusto posto tra le reali grandezze della letteratura mondiale» In Italia Keller è stato tradotto fin dai primi anni del XX secolo in varie edizioni. Sette Leggende fu tradotto la prima volta dal savonese di adozione Italo Scovazzi, mentre già precedentemente era stato tradotto Enrico il Verde. Di quest’ultimo abbiamo fin dal 1944 l’ottima traduzione di Lionello Vincenti, mentre tutte le novelle sono tradotte, e oggi radunate in due volumi editi da Adelphi, da Lavinia Mazzucchetti insieme alle traduzioni di Ervino Pocar, Anita Rho e Gianni Ruschena. Il lavoro di curatore e traduttore di Eugenio Giovannetti, che qui presentiamo e che è stato edito nel 1944, ci offre un saggio importante della maestria narrativa di Keller e certamente invoglia chi già non ha letto le altre sue opere a conoscere maggiormente questo grande narratore. Sinossi a cura di Paolo Alberti Dall’incipit del primo racconto Lettere d’amore perdute: Vittorio, Störteler (per i Seldwylesi semplicemente Viggi Störteler) viveva comodo e quieto, poiché aveva un prospero commercio di grossista e possedeva una perla di mogliettina, sana e tenera, che, oltre la propria gradevolissima persona, gli aveva portato anche un discreto patrimonio ereditato da fuori: e se ne stava col marito in operosa pace. Il capitale della buona Gritli gli faceva assai comodo per allargare gli affari ch’egli aveva a cuore di far fiorire. Aggiungete una proprietà, di natura assolutamente insolita in paese, ma che a lui intanto garbava assai. Aveva passato gli anni dello studio e qualche altro ancora in una grande città e s’era messo in un’associazione di giovani impiegati che si proponevano una coltura scientifica ed estetica, e, abbandonati a se stessi, ne combinavano di tutte. Leggevano i libri più strampalati, tra discussioni senza capo né coda: rappresentavano sul loro teatrino il Faust, il Wallenstein, l’Amleto, il Lear, il Nathan: promuovevano concerti difficili e s’infatuavano per articoli da far drizzare i capelli. Non c’era, insomma, coglioneria cui non fossero pronti Scarica gratis: Lettere d’amore perdute e altri racconti [https://liberliber.it/autori/autori-k/gottfried-keller/lettere-damore-perdute-e-altri-racconti/] di Gottfried Keller [https://liberliber.it/autori/autori-k/gottfried-keller/].
Scritto nel 1908, è un romanzo di fantasia che descrive un futuro (di fantasia) che ha fin troppe somiglianze con la storia reale degli anni successivi. La finzione romanzesca è quella di un diario di Avis Everhard, moglie del protagonista (Ernest Everhard) andato perduto e ritrovato sette secoli dopo l’epoca dei fatti. Il diario ha due parti ben distinte: la prima assomiglia più ad un saggio sociologico e politico e descrive con bella chiarezza le teorie socialiste dell’autore; la seconda, più breve, è un romanzo d’azione che descrive le peripezie dell’autrice del diario durante la ‘Prima rivolta’ e il massacro della Comune di Chicago. Il racconto si interrompe bruscamente e lascia in sospeso il destino dei protagonisti, anche se le numerose finte note del curatore che ha pubblicato il diario dopo sette secoli, racconta dell’imprigionamento ed esecuzione di Ernest. Sul web ci sono pagine (tra gli altri una intervista di Goffredo Fofi) che ripetono la notizia che Ernesto Che Guevara deve il suo nome di battesimo alla memoria del protagonista Ernest Everhard. Bella storia, ma non sono stato in grado di verificarne la fondatezza. Tra l’altro, il padre di Guevara si chiamava anche lui Ernesto Rafael. Come dicevo, può essere divertente cercare le somiglianze e le differenze tra quanto raccontato nel romanzo e la realtà storica: nel 1908, London prevedeva entro pochi anni la guerra mondiale, anche se lui la prevedeva tra gli Stati Uniti e la Germania, ma questa, dopo un primo attacco della flotta tedesca ad Honolulu (come i giapponesi a Pearl Harbour), non venne combattuta per lo sciopero generale proclamato nei due paesi dai socialisti. Nella realtà, nel 1914 i socialisti europei avrebbero voluto tentare la stessa cosa, ma non riuscirono per il rifiuto dei socialisti tedeschi. Altra somiglianza storica sono le ‘Centurie nere’ al servizio dell’oligarchia capitalistica, che effettuano spedizioni punitive arrivando da altre provincie e distruggendo le sedi delle organizzazioni socialiste e le tipografie che ne stampavano i giornali. Viene da pensare che i fascisti italiani usassero il libro come manuale per le loro imprese, come l’incendio della tipografia dell’”Avanti” nel 1919… Mi ha un po’ sorpreso l’importanza che London attribuiva al Partito Socialista Americano: se pensiamo ai due dopoguerra americani (la ‘Red Scare’ – paura rossa – seguente la rivoluzione bolscevica nel 1917-20 e il maccartismo degli anni ’50), oppure all’elezione di Trump, appare inverosimile, ma nei primi anni del ‘900 il movimento socialista negli Stati Uniti aveva davvero una sua importanza, anche se inferiore a quella attribuitagli dall’autore: alle elezioni presidenziali del 1912 Eugene Debs, il candidato socialista, ottenne il 6% con 900.000 voti. Sinossi a cura di Claudio Paganelli NOTE: Il testo è presente in formato immagine su “Internet Archive” (https://archive.org). Realizzato in collaborazione con il Project Gutenberg (https://www.gutenberg.org/) tramite Distributed Proofreaders (https://www.pgdp.net/). Dall’incipit del libro: La brezza d’estate agita i pini giganteschi, e le onde della Wild Water rumoreggiano ritmicamente sulle pietre muscose. Numerose farfalle danzano al sole e da ogni parte freme ed ondeggia il ronzio delle api. In mezzo ad una quiete così profonda, io me ne sto sola, pensierosa ed agitata. È tale e tanta la mia serenità, che mi turba, e mi sembra irreale. Tutto è tranquillo intorno, ma è come la calma che precede la tempesta. Tendo l’orecchio e spio, con tutti i sensi, il minimo indizio del cataclisma imminente. Purchè non sia prematuro, o purchè non scoppi troppo presto. La mia inquietudine è giustificata. Penso, penso continuamente, e non posso fare a meno di pensare. Ho vissuto così a lungo nella mischia, che la calma mi opprime, e la mia immaginazione prevede, istintivamente, quel turbine di rovina e di morte che si scatenerà ancora, fra poco. Mi pare di sentire le grida delle vittime, mi pare di vedere, come pel passato, tanta tenera e preziosa carne contusa e mutilata, tante anime strappate violentemente dai loro nobili corpi e lanciate verso Dio. Scarica gratis: Il tallone di ferro [https://liberliber.it/autori/autori-l/jack-london/il-tallone-di-ferro/] di Jack London [https://liberliber.it/autori/autori-l/jack-london/].
La colonizzazione moderna degli ebrei in Palestina fu in gran parte impostata su un’organizzazione di tipo collettivistico sia agricolo che industriale. L’inizio di questo indirizzo si trova fin dalle origini del sionismo politico: dal 1901 T. Herzl, che fu il principale propugnatore di questa linea, con la costituzione del Keren Kajameth le-Israel (Fondo nazionale ebraico) aveva dato il via all’acquisto inalienabile di terreni palestinesi da assegnare tramite un canone d’affitto molto basso ai coloni. Gli ebrei delle cinque alijòt (flussi migratori) che si susseguirono dal 1882 alla fondazione dello stato di Israele erano molto spesso animati da ideali socialisti e libertari e diedero grande impulso agli insediamenti collettivistici con l’idea di prefigurare il futuro assetto della rinata società ebraica. La prima colonia di questo tipo fu Degania fin dal 1909-1910. Le piccole colonie presero il nome di kevuzà; erano associazioni agricole di limitate proporzioni dal cui ampliamento e con l’estensione anche ad attività artigianali e poi industriali nacquero i kibbutz come si intendono ancora oggi. I primi kibbutz En Harod e Ten Josef furono fondati nel 1921. Gli sviluppi del movimento kibuzistico condussero alla formazioni di federazioni nelle quali si raggrupparono le colonie. Vi erano le federazioni ad orientamento socialdemocratico, quelle, in maggioranza, ispirantesi al sionismo socialista di D. B. Borochov; meno consistenti i raggruppamenti di ispirazione religiosa. La consistenza della popolazioni del kibbuz varia da circa 100 abitanti fino a 1200. La struttura interna esclude qualsiasi proprietà individuale (inizialmente escludeva anche qualsiasi forma di lavoro salariato); ognuno dà secondo le proprie capacità e riceve secondo i propri bisogni. Il coordinamento delle attività è fondato sull’assemblea di tutti i chaverím (compagni) su base volontaria e garantito da un comitato liberamente eletto e responsabile. Da sottolineare che fin dall’inizio dell’esperienza kibbuzistica era esclusa ogni disparità di genere. Fin dall’inizio della «rivoluzione sionista», i padri fondatori avevano promesso di creare una nuova «donna ebraica». Per un numero abbastanza ristretto di persone, ciò significò libertà sessuale, teorizzata e praticata in ambienti altrettanto ristretti. Per la maggioranza, fu l’inizio della fine della struttura familiare tradizionale: nei kibbutzim, in particolare, ma pure in comuni urbane. Tuttavia si può rilevare che l’accesso a nuovi lavori e lo stile di vita più libero non intaccarono comunque seriamente il ruolo dominante dell’uomo in campo economico. I maschi continuavano a svolgere i lavori più pagati e a monopolizzare quelli più legati alla produzione, dall’edilizia alle fabbriche. L’uguaglianza della donna rientrava nel discorso di ispirazione socialista del sionismo: la realtà fu piuttosto diversa. Per il trionfo delle rivoluzioni sionista e socialista, la donna dovette continuare a svolgere un duplice compito: oltre a sbrigare i lavori domestici, era anche una lavoratrice nei campi o nelle officine. Tutto questo comunque mentre l’organizzazione del “mandato britannico” in Palestina operava per la riproduzione dei meccanismi di funzionamento dell’economia vigenti in epoca tardo ottomana e agendo in direzione della trasformazione in senso capitalistico del mercato agricolo. Da sottolineare tuttavia che benché la maggior parte dei libri sulla Palestina durante il Mandato è solita iniziare dai primi giorni del conflitto che culminerà nella prima ondata di violenze dell’aprile 1920, va però tenuto presente il carattere riduttivo di tale descrizione. Negli spazi di relativa autonomia in cui viveva la maggior parte della popolazione, la religione e i valori spirituali esercitavano un’influenza assai più diffusa sull’esistenza delle persone di quella esercitata dai funzionari britannici o dai sionisti animati da spirito coloniale. E nel 1946, l’anno nel quale fu pubblicato il breve testo che presentiamo, nella Palestina rurale, ma non solo, era vivissimo il desiderio di collaborazione fra i popoli ebraico e palestinese. Quando ormai il mandato britannico stava per finire, insediamenti ebraici garantirono un sostegno più organizzato e strutturato ai villaggi palestinesi, e cooperative agricole congiunte – un’assoluta novità – sorsero nel Marg Ibn ’Amr negli anni Quaranta, tra kibbutzim e villaggi, mentre nelle città furono creati nuovi uffici commerciali congiunti. Troviamo infatti scritto nel capitolo Oasi nel deserto di questo libretto: «Quando si è scavato un pozzo artesiano con successo, l’acqua serve naturalmente anche per il villaggio arabo vicino. Questa è una delle ragioni per cui le relazioni tra le colonie ebraiche e i vicini Arabi sono generalmente buone.» In Palestina, la convivenza non fu solamente realizzata in circoli ristretti; fu anche una scelta ideale. Non godette di grande appoggio politico, anche perché non piacque a nessun uomo politico di grande rilevanza istituzionale. Fu tuttavia un pilastro teorico del Partito comunista di Palestina. Questo partito fu composto prevalentemente da ebrei sino al 1936, anno in cui, in seguito a quello che nella sua storia viene chiamato processo di «arabizzazione», iniziò ad aumentare il numero degli aderenti palestinesi. Nonostante il carattere marginale, questo partito contribuì a conferire un andamento alternativo allo sviluppo sociale diffondendo un discorso anazionale tramite i suoi giornali principali. L’organizzazione politica più apertamente favorevole al binazionalismo come stile di vita fu un piccolo gruppo denominato Brit Shalom (Patto di pace) e ideato da Yehuda Magness, un ebreo americano immigrato in Palestina nel 1922. Aderente all’American Reform Movement in ambito ebraico, Magness non era interessato alla sovranità degli ebrei sulla Palestina, bensì a che potessero viverci nell’ambito di uno Stato unitario binazionale. Sino alla morte, avvenuta nel 1948, Magness cercò di convincere entrambe le parti della ragionevolezza e della praticabilità della soluzione da lui proposta. Perciò creò un’organizzazione politica. Uno dei suoi più grandi successi, verso la fine del Mandato, fu convincere Fawzi al-Husaini, personalità di spicco della famiglia Husaini, ad aderire al movimento Brit Shalom. Fawzi al-Husaini fu però assassinato poco dopo dai suoi familiari schierati su posizioni nazionalistiche. Magness fu uno dei fondatori della Hebrew University e ne fu anche il primo presidente, nonostante il suo prestigio rimanesse però sempre relegato ai margini dell’attività sionista. Racconta Noam Chomsky: «Nel 1953 mia moglie e io vivevamo in un kibbutz in Israele; eravamo studenti, facevamo escursioni e un giorno ce ne andammo con lo zaino in spalla nella Galilea settentrionale. Eravamo in strada quando arrivò dietro di noi una jeep, un tizio uscì e si mise a gridare: «Dovete tornare indietro, avete sbagliato paese!». Eravamo entrati nel Libano. Oggi probabilmente ci accoglierebbero con le mitragliatrici spianate. Non ci dovrebbero essere frontiere in quell’area. Forse con il tempo questi confini decadranno; del resto, l’intero accordo imperialista Sykes-Picot comincia a vacillare. E potrebbero esserci sviluppi ulteriori, nel lungo periodo. A questo proposito, la soluzione a due Stati non andrebbe letta come una meta finale. Come ho detto prima, non è che gli Stati godano di una legittimità intrinseca; sono stati tutti imposti con la violenza, e continuano a generare violenza in tutto il mondo. È una struttura sociale inumana, e in quanto tale dovrebbe crollare, sempre. In questa prospettiva, il ritorno dei profughi non è più così irrealistico. Non sarebbe soltanto il riconoscimento di un torto storico, ma una vera interazione tra popoli, non basata sugli Stati, le religioni o le etnie. Ci sono altre basi su cui si può costruire questa interazione.» Tra il 1949 e il 1954 però il sistema di confisca di terre e villaggi da parte dei colonizzatori divenne insistente e il principale beneficiario di tale politica fu proprio il movimento socialista del kibbutz Hashomer Hatz’air che, ufficialmente, recava lo slogan della coesistenza binazionale bene in vista sui suoi striscioni. Era il più a sinistra dei tre maggiori movimenti del kibbutz attivi nel giovane Stato di Israele; dimostrò, nei fatti, di essere anche il più avido. Le conseguenze sono state inarrestabili. Per approfondire questi temi, qui appena superficialmente accennati, è molto utile leggere, ad esempio, il libro di Ilan Pappe, Storia della Palestina moderna. Una terra due popoli. Il breve testo che presentiamo fu edito in Italia nel 1946 a cura di Hechaluz, l’organizzazione dei giovani ebrei sionisti nata a Roma fin dal giugno 1944, non appena l’arrivo delle truppe alleate aveva allontanato i maggiori rischi per gli ebrei. Così viene descritta da Rav Urbach nel bollettino ebraico di informazione del 13 luglio 1944: «La nuova vita che pervade la Comunità ebraica dopo la liberazione ha avuto espressione immediata nella creazione di un Centro Giovanile Ebraico, che raccoglie a scopo di istruzione e ricreazione i giovani dai sette ai venticinque anni. Esso ha posto la sua sede in Via Balbo n.33. Circa 200 ragazzi si sono iscritti ai corsi di lingua e di cultura ebraica, che sono assai frequentati. Nel giugno 1944, a Via Balbo 33 dove c’era una Singagoga e dove per alcuni anni ero andato alla scuola ebraica, i soldati palestinesi cominciarono a organizzare dei corsi per i giovani ebrei italiani sul kibbutz, i movimenti giovanili, l’anelito di raggiungere Erez Israel mentre cantavamo le canzoni sentimentali in ebraico che tentavamo di capire. Tra gli insegnanti ricordo Joel Barromi e Yaakov [Foà] Ben Porat che erano vicini all’Hashomer Hazair, un movimento di kibbutzim di sinistra che fin da allora mi sembrava consono alle mie idee politiche.» L’intento del libretto è evidentemente propagandistico, ma senz’altro utile per aiutare a comprendere anche oggi il clima di entusiasmo attorno all’esperienza dei kibbutz e lo spirito collettivista che animava quella fase storica. Sinossi a cura di Virginia Vinci e Paolo Alberti Dall’incipit del libro: Le colonie collettiviste di Erez Israel sono non solo uniche nel mondo moderno ma sono anche le prime della loro specie nella storia. Molte epoche possono vantare degli esperimenti di vita in forma cooperativa, ma raramente essi hanno sorpassato lo stadio sperimentale e per lo più non riuscirono ad attrarre nuovi adepti all’infuori dei fondatori. Nessuno, per quel che si sa, ha saputo intessere qualche nuovo filo nella trama sociale, economica e politica del Paese dov’è sorto. Ci furono dei gruppi e delle associazioni i cui membri erano liberi ed uguali in un sistema di vita vago ed anarchico. Ma per lo più erano semplicemente dei mezzi per sfuggire alle convenzioni ed alle tradizioni della vita cosiddetta civilizzata. L’idea fondamentale conteneva raramente qualcosa di positivo; non vi era alcun ordinamento costruttivo che governasse la società. Lo spirito informatore era un non ben definito desiderio di liberarsi del vecchio sistema di vita ma non si aveva alcuna chiara idea di come si dovesse formare quello nuovo. Scarica gratis: La colonia collettivista in Palestina [https://liberliber.it/autori/autori-c/colonia-collettivista-in-palestina/la-colonia-collettivista-in-palestina/].
Probeer 7 dagen gratis
€ 9,99 / maand na proefperiode.Elk moment opzegbaar.
Exclusieve podcasts
Advertentievrij
Gratis podcasts
Luisterboeken
20 uur / maand