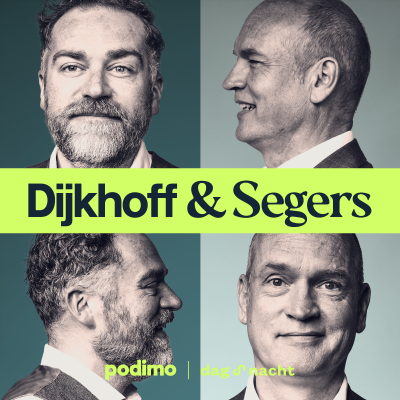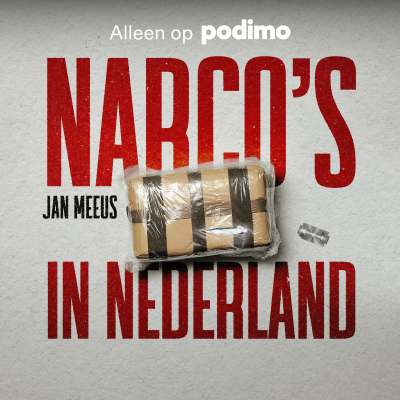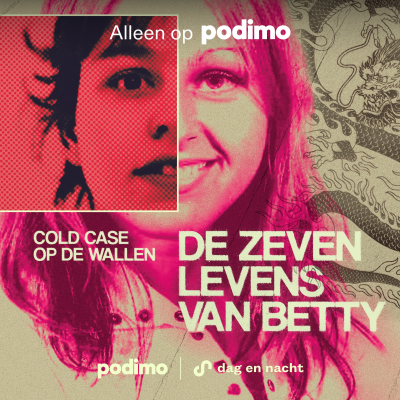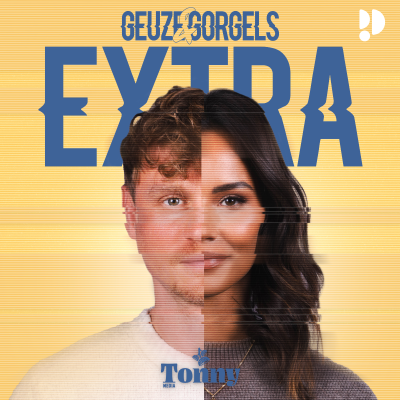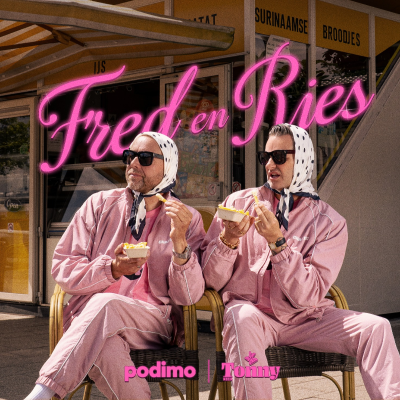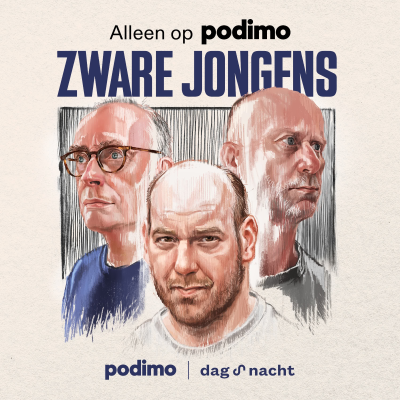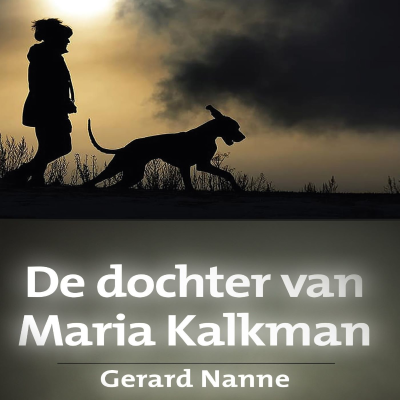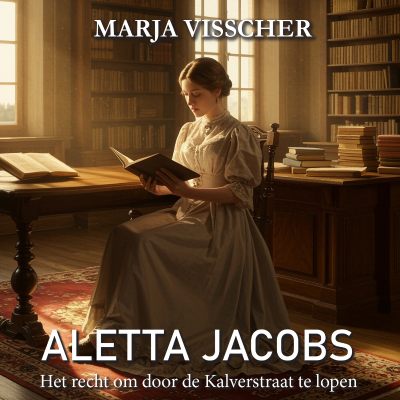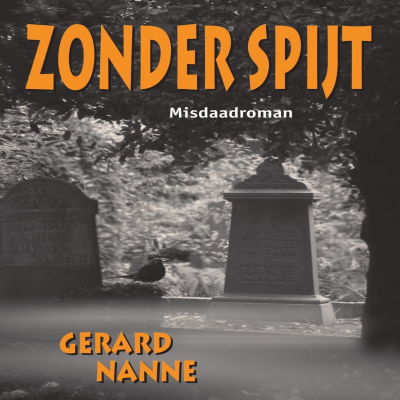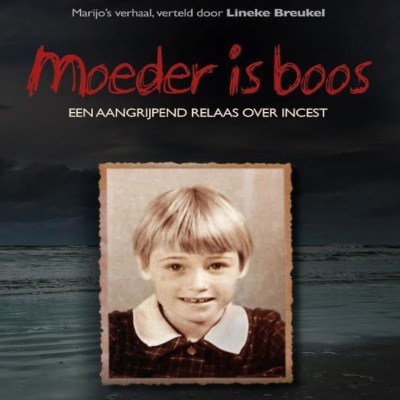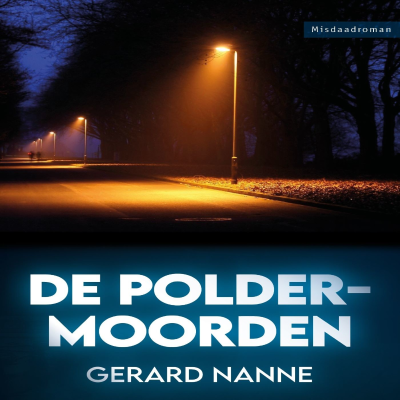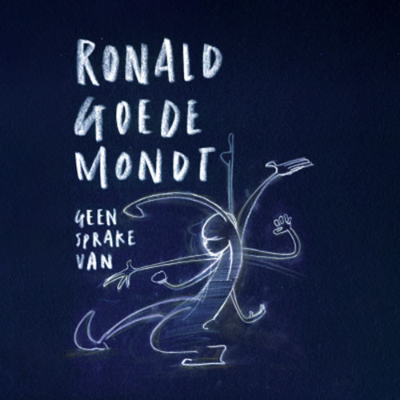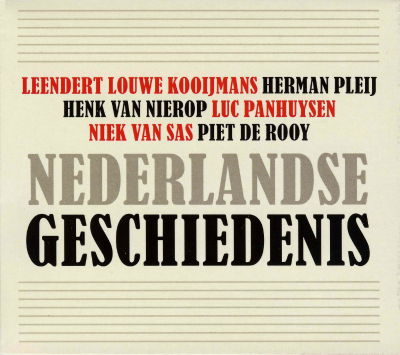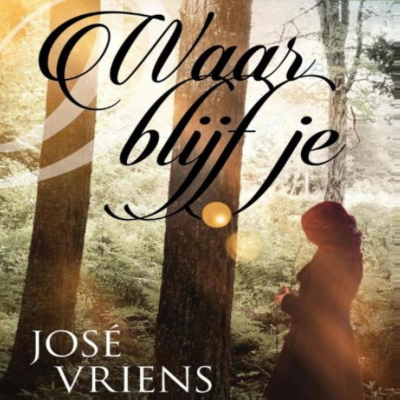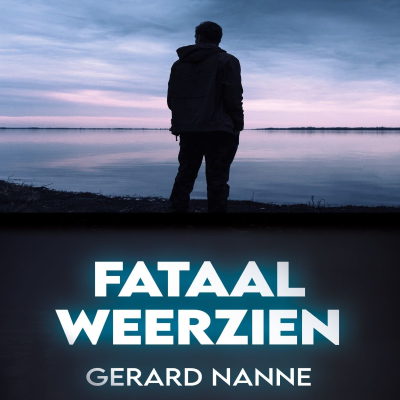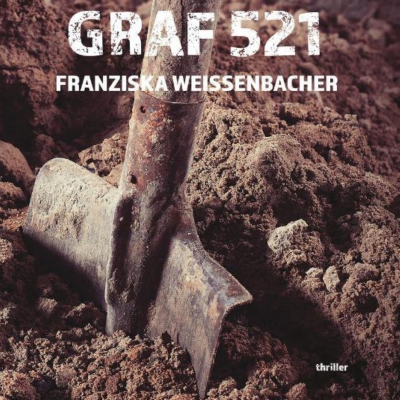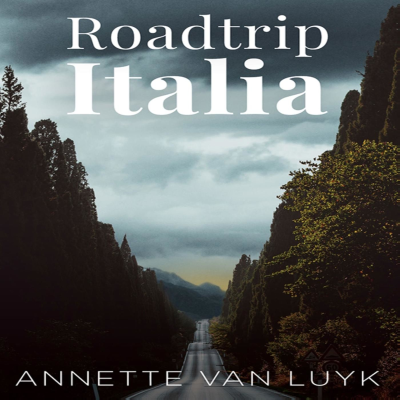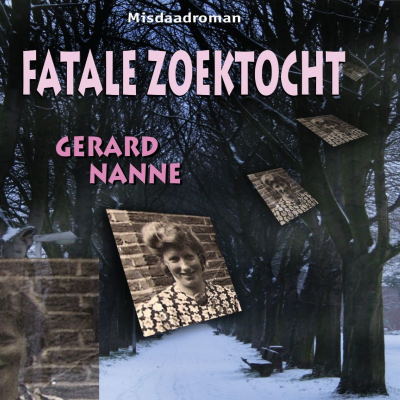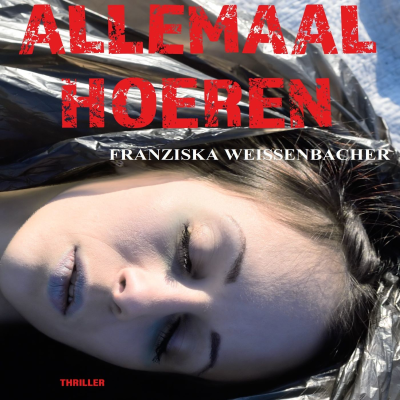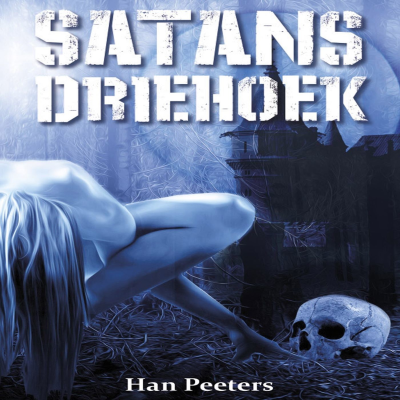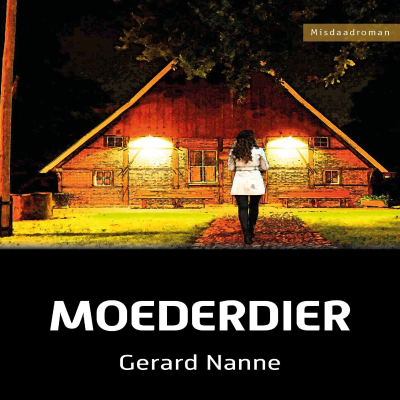Storia - BastaBugie.it
Italiaans
Geschiedenis & Religie
Tijdelijke aanbieding
2 maanden voor € 1
Daarna € 9,99 / maandElk moment opzegbaar.
- 20 uur luisterboeken / maand
- Podcasts die je alleen op Podimo hoort
- Gratis podcasts
Over Storia - BastaBugie.it
La storia che ci hanno insegnato a scuola è sbagliata; proviamo a guardare alla realtà dei fatti senza pregiudizi e senza paraocchi
Alle afleveringen
95 afleveringenL'inquisizione ne sapeva una più di Galileo
TESTO DELL'ARTICOLO ➜ https://www.bastabugie.it/8317 [https://www.bastabugie.it/8317] L'INQUISIZIONE NE SAPEVA UNA PIU' DI GALILEO di Giorgio Cavallo «Eppur si muove!»: uno degli aforismi più celebri della storia. Peccato che, come spesso le cose troppo belle celano un trucco, anche la storia di Galileo davanti all'Inquisizione nasconde una verità ben diversa: sotto la patina dell'aneddotica - e dell'aneddotica anticattolica - la storia dello scontro tra il più grande scienziato dei suoi tempi e l'Inquisizione sia profondamente diversa. Ecco come andarono le cose. Nella prima metà del XVII secolo, l'Europa attraversava un'intensa trasformazione culturale, politica e religiosa. La scoperta dell'America aveva cambiato la percezione geografica del mondo; la rivoluzione scientifica, con figure come Copernico, Keplero e anche il nostro Galileo, aveva messo in discussione la cosmologia aristotelico-tolemaica tradizionale. Infine, vi era la Rivoluzione protestante, metastasi sorta dalle eresie del secolo XV che, a differenza delle prime, era dilagata in tutto il Nord Europa e minacciava di mettere radici anche a sud delle Alpi. Come aveva risposto la Chiesa di fronte alle grandi sfide della sua epoca? Con la Controriforma, o Riforma cattolica, mediante quel lungo laboratorio che fu il Concilio di Trento (1545-1563), il quale aveva tra le altre cose rafforzato il ruolo dell'Inquisizione. GALILEO GALILEI Galileo Galilei (1564–1642), matematico e astronomo, si inserì in questo contesto come sostenitore del sistema eliocentrico copernicano, in aperta contraddizione con il modello geocentrico ancora ufficiosamente sostenuto dalla Chiesa. Ora, la questione qui si fa delicata e, per capirla, è opportuno comprendere il pensiero della Chiesa sempre alla luce delle grandi rivoluzioni scientifiche, geografiche e della geo-politica di allora. I papi - o, per meglio dire, i loro esperti - ritenevano davvero che la Terra potesse essere al centro dell'universo, rifiutando le tante evidenze scientifiche? Ecco, proprio qui sta il bello: la teoria eliocentrica, infatti, per quanto stimolante non aveva ancora delle prove scientifiche che potessero dimostrarne la bontà. Per assurdo: non le aveva Copernico, non le aveva Galileo. Quando, messo alle strette, lo scienziato pisano dovette provare le sue affermazioni dati alla mano, si inventò le cose più assurde, tirando in ballo anche le maree come evidenza del fatto che la Terra girasse attorno al Sole e non viceversa. Noi sappiamo che la prova definitiva sulla materia arrivò soltanto con l'esperimento del pendolo di Foucault, presentato al pubblico di Parigi soltanto nel 1851. Galileo non poteva che arrampicarsi sugli specchi, perché sapeva di essere nel giusto ma sapeva anche di non poterlo dimostrare. E la Chiesa, purtroppo, sapeva che Galileo poteva essere nel giusto ma sapeva anche di non poterlo affermare: non si trattava di uno scontro tra scienza e fede, come spesso è stato dipinto; si trattava di buonsenso. Nell'Europa di allora, dilaniata dalle guerre di religione, un'apertura verso una nuova teoria scientifica da parte del Papa avrebbe significato dare fuoco alle polveri di un nuovo scontro ideologico tra cattolici e protestanti. Perché sì, nel Nord Europa i protestanti si facevano davvero scudo con i Testi Sacri che, essendo stati tradotti per la prima volta da Lutero erano ora di libero accesso a molte più persone. Già le teorie di Copernico, pubblicate postume nel 1542, avevano suscitato un vespaio di polemiche nei territori protestanti. COPERNICO ERA CATTOLICO Piccola annotazione: Copernico era cattolico ed era canonico della cattedrale di Frauenburg, avendo preso gli ordini minori. Roma dava ospitalità (e rifugio) a molti scienziati. I papi non hanno mai rifiutato di confrontarsi con la scienza; semmai, all'epoca, era vero il contrario: le dittature teologiche come quella instaurata da Calvino a Ginevra tutto erano, fuorché "aperte" e "dialoganti" con il pensiero scientifico moderno. Per paradossale che possa sembrare, dunque, la Roma dei papi costituiva uno dei baricentri del sistema scientifico di allora, mentre l'Europa protestante, per giunta devastata dalle guerre di religione, non poté per molto tempo essere considerata all'avanguardia su questo punto. Certo, c'era uno scotto da pagare anche in terra cattolica. Vale a dire: non si era liberi di affermare pubblicamente la verità di studi e ricerche scientifici che non fossero validamente provati in modo inconfutabile. Ma, a ben pensarci, è sempre la solita questione di buon senso: non soltanto per evitare scontri scientifico-teologici con il mondo protestante, quanto per non propagandare teorie sbagliate, con gravi ripercussioni su tutti. Roma non avrebbe potuto "metterci la faccia"; temendo di incorrere in un errore madornale, come quel tale che andò in Occidente per giungere in Oriente e che in mezzo trovò un continente sconosciuto, i papi semplicemente ripiegarono sull'usato sicuro. E cioè la teoria geocentrica che, perlomeno, godeva della confortante protezione data dai grandi dell'antichità. Torniamo però a Galileo, che non si limitava soltanto a scrivere saggi ma che insegnava la teoria eliocentrica in università (e le università erano state fondate ed erano gestite dalla Chiesa). Nel 1616 la Congregazione del Sant'Uffizio esaminò le tesi copernicane con un vero e proprio esame scientifico. Il cardinale Roberto Bellarmino era, d'altronde, uno dei più grandi cervelli della sua epoca. Il futuro santo e Dottore della Chiesa comunicò a Galileo che non avrebbe potuto sostenere né insegnare pubblicamente la dottrina eliocentrica come vera, ma solo come ipotesi matematica. Galileo fu dunque invitato alla prudenza. Nel 1632, Galileo pubblicò il Dialogo sopra i due massimi sistemi del mondo, che ottenne anche l'imprimatur da Roma mediante l'intercessione nientemeno che del Papa Urbano VIII Barberini. Questi, quando era ancora cardinale, aveva protetto l'eretico Tommaso Campanella ed aveva sempre dimostrato una grande apertura verso le ricerche scientifiche. Urbano VIII aveva dimostrato anche la sua buona volontà anche verso Galileo, ma le cose andarono in modo diverso. In primo luogo, il contenuto dell'opera di Galileo fece storcere il naso a molti: la figura di Simplicio, portavoce delle idee tolemaiche e apparentemente ridicolizzato nel testo, fu percepita come una sfida diretta all'autorità della Chiesa e la diffusione dell'opera fu, per quanto possibile, ostacolata. Il 12 aprile 1633 Galileo fu quindi convocato a Roma per affrontare il processo. Il fulcro dell'accusa non era tanto il contenuto scientifico del Dialogo, ma la presunta violazione dell'ammonizione del 1616. La Santa Inquisizione sostenne che Galileo avesse infranto un ordine diretto di non trattare la dottrina copernicana in alcun modo. EPPUR SI MUOVE: GALILEO NON L'HA MAI DETTO Nuovamente, la questione di Galileo appare paradossale: lo scienziato pisano si era esposto pubblicamente senza assecondare quell'invito alla prudenza che, nel suo caso, doveva apparire come un imperativo morale in quanto cattolico. Galileo aveva quindi rifiutato di sottostare al Papa, preferendo la via dello scontro frontale. Non era soltanto una questione di carattere (e il carattere di Galileo era notoriamente pessimo) ma di forma e di metodo; ed era in gioco anche il modo di interpretare la scienza. In parole povere: Galilei si faceva schermo della scienza per poter affermare ciò che voleva, andando contro anche ai fraterni ammonimenti del Papa. Con il senno di poi, Galileo si poneva verso la scienza con la sicumera di uno scientista, cioè di colui che eleva la scienza a metro di giudizio del mondo. Ma lo scientismo non è scienza: è dottrina, è fanatismo. Perché la scienza può sbagliare ed, anzi, il metodo scientifico si basa proprio sulla possibilità di sperimentare e quindi di saggiare gli errori. Questa era la posizione della Chiesa che, quindi, era più... scientifica di Galileo! E Galileo, che per altro si era invischiato in questioni teologiche che non gli competevano, il 22 giugno 1633 fu costretto ad abiurare pubblicamente le sue convinzioni. La cosa si esaurì lì: tanto rumore per nulla. Galileo fu condannato alla recita settimanale dei sette Salmi penitenziali per tre anni e alla "reclusione" nella villa dell'ambasciatore del granducato di Toscana, poi in quella dell'arcivescovo Piccolomini a Siena ed infine nella villa posseduta dallo stesso Galileo ad Arcetri. Per altro, l'insostenibile penitenza della recita quotidiana dei Salmi penitenziali fu poi sgravata dalle sue spalle e assegnata alla figlia Maria Celeste, che era suora di clausura. Era evidente che la Chiesa volesse risolvere la questione senza scandalo; semmai, a gettare benzina sul fuoco furono coloro che lessero il "caso Galileo" come uno scontro tra scienza e fede. Cosa che non fu: all'epoca si riteneva ancora che si potesse fare scienza in seno alla Chiesa e che, anzi, la stessa teologia fosse una scienza. I detrattori del cattolicesimo si inventarono la tortura di Galileo (mai avvenuta) e anche il celebre aforisma «Eppur si muove», che compare per la prima volta tra le pagine di Giuseppe Baretti, polemista del secolo XVIII. Ed infine, la beffa: il caso Galileo, come scontro titanico di un uomo, rappresentante della Scienza, contro la Chiesa Cattolica, divenne così celebre che fu tra i primi documenti trafugati dai giacobini al momento dell'invasione degli Stati Pontifici. Pare che i fascicoli processuali passarono nientemeno che tra le mani di Napoleone, il quale li lesse con attenzione. E poi? Tornarono a Roma fortemente lacunosi: il fascicolo dell'Archivio Apostolico Vaticano manca delle parti f
Papa Francesco non chiuderà il giubileo
TESTO DELL'ARTICOLO ➜ https://www.bastabugie.it/8156 [https://www.bastabugie.it/8156] PAPA FRANCESCO NON CHIUDERA' IL GIUBILEO (ACCADDE SOLTANTO A INNOCENZO XII) di Cristina Siccardi Papa Francesco ha aperto la porta Santa in San Pietro, dando inizio all'Anno Santo ordinario del 2025, la Vigilia di Natale dello scorso anno. Era in sedia a rotelle e le campane suonavano a festa. Il 21 aprile, il Lunedì dell'Angelo, dopo la Santa Pasqua, le campane di San Pietro, invece, hanno suonato a morto per la sua scomparsa, avvenuta a 88 anni di età. Il giorno prima ha voluto incontrare, a sorpresa, il vice presidente degli Stati Uniti JD Vance, poi è apparso dal loggione per impartire la benedizione Urbi et Orbi che ha pronunciato con un filo di voce e al termine è sceso in piazza sulla Papa-mobile tra la folla dei fedeli. È stato il suo ultimo saluto: poche ore dopo, alle 7,35, si è spento. Secondo le sue volontà non sarà sepolto in Vaticano, bensì nella basilica di Santa Maria Maggiore, una delle quattro basiliche Papali di Roma. Papa Francesco, che aveva già indetto il Giubileo straordinario della Misericordia nel 2015, non potrà chiudere l'Anno Santo nella data prevista, il 6 gennaio 2026. UNICO PRECEDENTE A un solo altro Pontefice accadde la stessa sorte: era Innocenzo XII (1615-1700), nato Antonio Francesco Pignatelli, che morì a 85 anni. Durante il suo pontificato la vita dei popoli europei fu spesso funestata dalle guerre. Il Papa indisse il Giubileo il 18 maggio 1699 con la bolla Regi Saeculorum e all'apertura, a causa delle sue precarie condizioni di salute, non poté presiedere personalmente; ma nel giorno di Pasqua di quell'anno, pur essendo ormai gravemente malato, a causa del gran numero di pellegrini venuti da tutte le parti impartì la benedizione solenne dal balcone del Quirinale. Morì il 27 settembre del 1700, quindi l'Anno Santo fu chiuso dal suo successore, Clemente XI (1649-1721), nato Giovanni Francesco Albani. Nonostante l'assenza del Papa, sostituito dal cardinale Emmanuel de Bouillon (1643-1715), la cerimonia di apertura del Giubileo si svolse solennemente alla presenza della regina di Polonia, María Cristina (1641-1716), vedova del sovrano Jan Sobieski, e dal granduca di Toscana, Cosimo III de' Medici (1642-1723). La regina era entrata in San Pietro scalza e vestita da penitente e l'enorme affluenza di fedeli passava in ginocchio attraverso la Porta Santa. Membro di un casato aristocratico, Antonio Pignatelli, nato a Spinazzola in Puglia, trascorse tutto il periodo di formazione a Roma nel Collegio dei Gesuiti, dove prese gli ordini sacri probabilmente nel 1643. Si laureò in utroque iure e papa Urbano VIII lo chiamò a svolgere le sue mansioni nella Curia romana. Fu ordinato vescovo il 27 ottobre 1652. Svolse la carriera diplomatica come nunzio apostolico e per undici anni, dal 1660 al 1671, risiedette all'estero, tra Confederazione polacco-lituana e Impero austriaco. Fu creato cardinale il 1º settembre 1681 da Innocenzo XI. Come porporato partecipò a due conclavi, nel 1689 e nel 1691, quando fu eletto successore di San Pietro. Convinto della necessità che il clero dovesse porsi a modello dei fedeli, il Pontefice fece pubblicare la costituzione apostolica Sanctissimus in Christo Pater (18 luglio 1695), con la quale richiese a ogni ordine religioso una più stretta osservanza delle regole e una più attenta preparazione dei giovani nei noviziati. Attento alla Liturgia, il 20 agosto 1692 emise un decreto sulla musica sacra, in tal modo dissipò la confusione causata dalle diversità di interpretazioni e illuminando tutta la questione. CONTRO IL NEPOTISMO E IL GIANSENISMO Innocenzo XII è passato anche alla storia per aver emanato, il 23 giugno 1692, la bolla Romanum decet pontificem con la quale si eliminava ogni pratica di nepotismo, proibendo di fatto ai pontefici di concedere proprietà, incarichi o rendite a qualsiasi congiunto; inoltre, nessun parente di essi avrebbe più potuto essere innalzato al cardinalato. Sotto il suo pontificato proseguì l'annosa controversia giansenista, che egli condannò fermamente come eresia nel 1699. Cultore mariano, il 15 maggio 1693, stabilì che tutte la chiese celebrassero la festa dell'Immacolata Concezione con un'ottava. Realista e cosciente dei pericoli musulmani che gravitavano sui popoli d'Europa, appoggiò l'Imperatore del Sacro Romano Impero Leopoldo I d'Asburgo (1640-1705), impegnato nella guerra contro l'Impero Ottomano nella Grande guerra turca (1683-1699). Dopo più di un decennio di duro conflitto, Leopoldo uscì vittorioso in Oriente grazie al geniale talento militare del principe Eugenio di Savoia-Soissons (1663-1736). Con il trattato di Karlowitz, l'Imperatore cristiano recuperò quasi tutto il Regno d'Ungheria, che era caduto sotto il potere turco negli anni successivi alla battaglia di Mohács del 1526. Attento non alle demagogie, ma ai concreti bisogni della Chiesa, Innocenzo XII riformò l'apparato giudiziario per rendere efficace ed efficiente l'azione dei tribunali romani, troppo lenti nel garantire la giustizia. Con la bolla Ad radicitus submovendum del 31 agosto 1692 soppresse tutti i tribunali e i giudici particolari e rimise tutte le cause ai giudici ordinari. Fece quindi erigere un palazzo a Montecitorio, dove concentrò tutti i tribunali dell'Urbe, l'attuale Palazzo Montecitorio, inaugurato nel 1696. Uomo di poche parole, ma dai molti fatti, nel 1692 fece realizzare il nuovo acquedotto di Civitavecchia, dichiarò porto franco lo scalo portuale e le conferì il titolo di Città. Ordinò la costruzione del porto di Anzio (soprannominato «di Nettuno»), che portò crescita e sviluppo del luogo. Fece anche aprire due dogane a Roma, una per il traffico di merci via acqua, presso il porto di Ripa Grande, l'altra per le mercanzie via terra, nel tempio di Adriano a piazza di Pietra e, come non bastasse, rafforzò le difese militari sulla linea di costa per contrastare la minaccia dei Corsari barbareschi. Nel 1693 decise di riorganizzare l'assistenza pubblica di Roma e iniziò con il raccogliere l'infanzia abbandonata in un'unica istituzione, progettando di concentrarvi anche le altre categorie di poveri assistiti. Nacque così il nucleo di quello che divenne l'Ospizio apostolico di San Michele a Ripa Grande. Proprio in occasione del Giubileo del 1700, fece aprire un nuovo raccordo viario tra la via Appia antica e la via Campana, oggi via Appia Nuova, nota ancora oggi come Appia Pignatelli. Patrono delle Arti e delle Scienze, dopo la sua morte, il suo amico e conterraneo, il cardinale don Vincenzo Petra (1662-1747) dei duchi di Vastogirardi, commissionò all'architetto Ferdinando Fuga un monumento funebre in suo onore in San Pietro, presidiato da due statue, opera dello scultore Filippo Valle, che rappresentano la Giustizia e la Carità.
Le guardie svizzere al servizio del successore di Pietro
VIDEO: Il giuramento delle Guardie Svizzere ➜ https://www.youtube.com/watch?v=9_oxmm_y09Y&list=PLolpIV2TSebUYAolUy8XGKkkSVK1dUyXF TESTO DELL'ARTICOLO ➜ https://www.bastabugie.it/it/articoli.php?id=7957 LE GUARDIE SVIZZERE AL SERVIZIO DEL SUCCESSORE DI PIETRO di Alberto Carosa Il 6 maggio 1527 è passato alla storia non solo come l'inizio dell'infame Sacco di Roma, ma anche come il giorno del primo autentico "battesimo di fuoco" per il corpo di guardie svizzere pontificie che aveva cominciato a servire il Papa e il Papato un paio di decenni prima. Ma perché reclutare soldati proprio dalla Svizzera? Perché storicamente gli svizzeri sono famosi per le loro capacità in due particolari mestieri: fare orologi e fare la guerra. I mercenari svizzeri si mettono in luce particolarmente nel XV secolo, dedicandosi per lungo tempo all'attività militare mercenaria quale sbocco alla loro povertà. La loro forza d'animo, nobili sentimenti e proverbiale spirito di fedeltà ne faceva dei combattenti ritenuti invincibili. Le loro formazioni semplici e primitive in quadrati massicci, che richiamavano la testuggine romana, armati di picche, si opponevano come istrici dai lunghi aculei agli attacchi della cavalleria, segnandone l'inizio del declino come arma decisiva. Tutte queste doti e in particolare lo spirito di fedeltà, rispetto alle altre truppe mercenarie del tempo, trovarono piena conferma, se pur ce ne fosse stato bisogno, quel giorno, che era cominciato con l'assalto mattutino alle mura vaticane di Borgo tra il Gianicolo e il Vaticano, da parte delle truppe imperiali di Carlo V al comando del duca Carlo di Borbone. ROMA ATTACCATA Ma come si era giunti a questo assalto alla Città eterna? L'ordine era venuto dallo stesso Imperatore Carlo V, che in tal modo volle punire il Papa Clemente VII per il voltafaccia con cui aveva aderito alla Lega Santa di Cognac, alleandosi al Re di Francia, Francesco I di Valois (a sua volta alleato con i turchi), in funzione anti-imperiale. Papa Clemente temeva infatti, che le mire espansionistiche del sovrano asburgico mettessero a rischio la stessa esistenza dello Stato Pontificio come entità territoriale. Il Conestabile di Borbone e la sua orda selvaggia, in gran parte lanzichenecchi tedeschi protestanti già sotto il comando del generale Giorgio von Frundsberg (costretto ad abbandonare il campo anzitempo per motivi di salute), dovevano prendere la città in fretta, per evitare di essere intrappolati a loro volta dall'esercito della Lega, che avrebbe potuto tagliargli la via della ritirata. Poiché forse l'assalto non procedeva secondo i tempi previsti, il Borbone decise di andare a spronare personalmente i suoi soldati che si disponevano a scalare le mura alla Porta del Torrione. Ma mettere tanto zelo in un'impresa del genere non fu una buona idea: una palla d' archibugio (che poi Benvenuto Cellini si vantò d' aver tirato) lo colpì a morte. Dopo un attimo di sbandamento, gli assalti ripresero più furiosi di prima e i mercenari spagnoli (6000 effettivi, il reparto più consistente dopo i lanzichenecchi) sfondarono la Porta del Torrione, mentre i lanzichenecchi dilagavano per Borgo S. Spirito e S. Pietro. La Guardia Svizzera, compatta ai piedi dell'obelisco che allora si trovava vicino al Campo Santo Teutonico, e le poche truppe romane resistettero eroicamente. UN GLORIOSO MARTIRIO Dopo l'eccidio di tutti i soldati di guardia, mentre per il corridoio il Papa si metteva al sicuro, gli svizzeri ancora resistevano, difendendo S. Pietro. Alla loro testa era il comandante Kaspar Röist. Le orde non rispettarono il luogo santo e feroce si riaccese la mischia. Tutti caddero fino all'ultimo e con essi la consorte del comandante Röist, mutilata prima delle braccia, poi uccisa sul cadavere del marito. Dell'intero corpo, 189 svizzeri, se ne salvarono solo 42, quelli che erano di servizio quel giorno nel palazzo apostolico e quindi col compito di scortare il Papa al sicuro in Castel S. Angelo. Infatti il loro supremo sacrificio non fu vano, perché guadagnarono il tempo sufficiente al Papa per mettersi in salvo attraverso il "Passetto", un corridoio segreto costruito da Alessandro VI sul muro che collegava il Vaticano con Castel Sant'Angelo. A suggello del loro supremo sacrificio, equivalente a un vero e proprio martirio, i 147 svizzeri si coprirono di eterna gloria cadendo eroicamente proprio sui gradini dell'altare maggiore di S. Pietro, quasi a simboleggiare l'unione dell'offerta del loro sangue a quella che Nostro Signore rinnova in maniera incruenta in ogni celebrazione della Santa Messa. ROMA IN MANO AI BARBARI PROTESTANTI Attraverso Ponte Sisto, poi, i lanzichenecchi e gli altri mercenari al seguito si riversarono sulla città, e per otto giorni diedero libero sfogo a ogni sopruso e efferatezze possibili e immaginabili: omicidi, torture, stupri, rapine, sequestri di persona a scopo di estorsione, saccheggi, devastazioni, incendi, accanendosi particolarmente nello sfregio di luoghi e oggetti sacri e nelle offese a quanti vestissero un abito religioso. La violenza fu tale che appena qualche giorno dopo, il 10 maggio, l'estensore di una relazione alla Repubblica veneta scriveva: «L'inferno è nulla in confronto colla vista che Roma adesso presenta». I morti pare siano stati dodicimila nei primissimi tempi, cui vanno aggiunte le svariate centinaia, se non migliaia, di altre vittime della peste che scoppiò quasi contemporaneamente, vuoi a causa dei molti cadaveri insepolti e mangiati dai cani, vuoi per le condizioni e le abitudini promiscue della soldataglia (che ne fu a sua volta ampiamente decimata). Il valore complessivo del bottino si sarebbe poi aggirato - secondo le stime dello stesso Clemente VII - intorno alla cifra esorbitante di dieci milioni di ducati d'oro. Ma ingenti furono anche - sul piano più prettamente culturale - i danni subiti dagli archivi e dalle biblioteche, dai tesori delle chiese e dalle raccolte d'arte; furono profanate perfino le tombe dei Papi, compresa quella di Giulio II, per rubare il loro contenuto. Oltre al danno irreparabile della distruzione di reliquie, andò perduto anche un tesoro d'arte inestimabile, ossia la maggior parte dell'oreficeria artigiana di chiesa. Ad ulteriore sfregio, i lanzichenecchi adibirono san Pietro a stalla per i loro cavalli. Non c'è da meravigliarsi troppo di tutto questo perché l'esercito imperiale, e in particolare i lanzichenecchi, erano animati da uno spirito di crociata antipapista, anche se erano al soldo di un monarca cattolico; infatti il Frundsberg non aveva fatto mistero di voler prendere Roma per impiccare il Papa e i suoi cardinali. "VIVAT LUTHERUS PONTIFEX" Non mancarono poi quanti interpretarono gli avvenimenti come un segno dell'ira di Dio per le divisioni dei cristiani a seguito della rivoluzione protestante. Davanti a Castel Sant'Angelo, sotto gli occhi del Papa, fu poi imbastita una parodia di processione religiosa, con la quale si chiedeva che Clemente cedesse a Lutero vele e remi della "Navicella" di Pietro. Allora la soldataglia gridò: "Vivat Lutherus pontifex". Per sfregio, il nome di Lutero fu inciso con la punta d'una spada sull' affresco La Disputa del Santissimo Sacramento nelle Stanze di Raffaello, mentre un altro graffito inneggiava a Carlo V Imperatore. Conciso e esatto il giudizio del priore dei canonici di S. Agostino emesso allora: «Mali fuere Germani, pejores Itali, Hispani vero pessimi»: i tedeschi furono cattivi, peggiori gli italiani, pessimi gli spagnoli. Ad accrescere la ferocia dei vincitori contribuì forse anche il mancato pagamento della "cinquina", ossia il soldo che a quei tempi veniva pagato ogni cinque giorni. Quando però il comandante delle truppe non disponeva di danaro sufficiente, autorizzava il cosiddetto "sacco" della città, che in genere non durava più di una giornata. Nel caso specifico, la soldataglia era rimasta senza paga, senza comandante e senza ordini, e poté quindi più facilmente abbandonarsi ad un saccheggio così sfrenato e prolungato. UN MERITO CHE NON SI DIMENTICA La notizia del Sacco di Roma commosse l'intera Europa ed ebbe grande impatto emotivo e vasta eco presso i contemporanei, tanto che ne rimane traccia in un'articolata pubblicistica. Lo stesso Carlo V ne rimase indignato e fece sospendere le feste indette in Spagna per la nascita del figlio Filippo, fece fare preghiere per la liberazione del Pontefice (come se non fosse suo prigioniero) e scrisse al Re d'Inghilterra e agli altri principi che le violenze erano state commesse contro la sua volontà. La soppressione della Guardia Svizzera, sostituita da una compagnia di 200 lanzichenecchi, fu tra le condizioni imposte a Clemente VII per la resa, ma egli ottenne che gli svizzeri sopravvissuti fossero inclusi nel nuovo corpo. Però solo dodici accettarono, mentre gli altri non vollero avere niente a che fare con gli odiati mercenari tedeschi. La Guardia Svizzera fu reintegrata nella pienezza dei suoi compiti da Paolo III il 3 febbraio 1548, quando un contingente di 225 confederati tornò a servire il Papa su base permanente. E se oggi la Guardia Svizzera è ancora al suo posto dopo le riforme seguite al Concilio Vaticano II, che hanno portato invece all'abolizione di altri corpi armati vaticani, lo si deve anche al ricordo indelebile dell'eroico sacrificio dei suoi 147 membri cinque secoli fa, luminoso esempio di spirito cavalleresco e fedeltà incrollabile al servizio del Papa e del Papato fino alle ultime conseguenze. Nota di BastaBugie: nell'articolo seguente dal titolo "A cosa servono le guardie svizzere" si spiega il ruolo che hanno ancora oggi
La Francia è consacrata a Maria Assunta
TESTO DELL'ARTICOLO ➜ https://www.bastabugie.it/it/articoli.php?id=7908 [https://www.bastabugie.it/it/articoli.php?id=7908] LA FRANCIA E' CONSACRATA A MARIA ASSUNTA di Francesco Patruno Nei giorni scorsi, durante le Olimpiadi svoltesi a Parigi, abbiamo assistito a una derisione del Cristianesimo nella cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici, tenutasi il 26 luglio. Gli organizzatori hanno voluto scimmiottare l'Ultima Cena. [...] Il carattere esoterico e neo-gnostico della cerimonia era evidente, perché, non a caso, la sua figura centrale era quella del dio pagano Dioniso, che per Friedrich Nietzsche e per gli esoteristi, incarnerebbe l'antitesi del Cristo e rappresenterebbe il simbolo della rottura con la morale cristiana, vista come avvilimento ed annientamento. [...] Guardando a questi spettacoli, così in contrasto con ciò che la Francia un tempo ha rappresentato per la Chiesa e per la fede cattolica, che ha visto germogliare in terra francese schiere di santi, tanto da essere considerata “figlia primogenita della Chiesa”, mi sono chiesto se essi riflettano davvero il popolo francese e le radici di quel paese. A un'analisi superficiale, potrebbe sembrare che quella Nazione non potrà mai tornare ai suoi fasti cristiani. Eppure, c'è speranza. Non dobbiamo dimenticare Colei che tutte le generazioni chiamano beata, a cui la Francia fu affidata secoli fa; un affidamento legato proprio alla solennità dell'Assunzione. Un affidamento che potrebbe costituire, secondo i tempi imperscrutabili della Vergine, che sono i tempi di Dio, il perno su cui la terra di Francia tornerà a essere pienamente cristiana. Cosa c'entra, dunque, quella Nazione con l'Assunta? È presto detto. Si tratta di una storia davvero affascinante, risalente al XVII sec., cioè alle vicissitudini private (e non solo) del re Luigi XIII e della regina Anna d'Austria. Sì, proprio quell'epoca e quei regno durante il quale è ambientata anche la vicenda de I tre moschettieri di Alexandre Dumas. Per farla breve, la coppia, molto pia e devota (sebbene il re non avesse mancato di intrattenere relazioni con cortigiane), non era stata benedetta dalla nascita di un figlio che potesse garantire la successione al trono. Per la verità, dal matrimonio, la regina concepì ben tre figli, che si risolsero in altrettanti aborti, di cui uno accidentale per una caduta dalle scale. La coppia regale, quindi, non poteva godere della gioia di un erede al trono. Fu su consiglio del monaco agostiniano scalzo Fra Fiacre di Sainte-Marguerite, personalità mistica dell'epoca, che aveva ricevuto nell'autunno 1637 alcune apparizioni della Vergine nelle quali la Madonna annunciava la prossima nascita di un erede al trono ed invitava - suo tramite - a tale scopo la regina Anna a compiere dei cicli di novene (il ciclo di novene si concluse il 5 dicembre di quell'anno, esattamente nove mesi dopo nacque il tanto desiderato bambino), e dell'ex cortigiana e confidente del re, Louise de La Fayette, divenuta nel frattempo monaca visitandina col nome di Suor Angelica, la quale aveva favorito la riconciliazione e la riunione del re con la regina, se si giunse - una volta avuta la certezza del concepimento del figlio da parte della sovrana - alla proposizione di un voto alla Madre di Dio. IL VOTO ALLA VERGINE Per la verità, sin dall'indomani del concepimento del figlio (avvenuto - si badi - dopo oltre un ventennio di matrimonio sostanzialmente sterile), e cioè dall'11 dicembre 1637, il re annunciava la sua intenzione di esprimere un voto alla Vergine. Il testo, più volte corretto e rifinito anche dal primo ministro del re, il celebre cardinal de Richelieu, fu sottoposto al Parlamento di Parigi. Il 10 febbraio 1638, finalmente, il re, nel suo castello di Saint-Germain-en-Laye, firmava, con proprie lettere patenti, il testo del voto in cui dichiarava solennemente che, «prendendo la santissima e gloriosissima Vergine come speciale protettrice del nostro regno, a Lei consacriamo particolarmente la nostra persona, il nostro Stato, la nostra corona e i nostri sudditi, supplicandola di ispirarci una santa condotta e difendere questo regno con tanta cura contro gli sforzi di tutti i suoi nemici [...]. E affinché i posteri non possano non seguire i nostri desideri su questo argomento, come monumento e segno immortale dell'attuale consacrazione che compiamo, faremo riedificare il grande altare della cattedrale di Parigi con un'immagine della Vergine che tenga tra le sue braccia quelle del suo prezioso Figlio deposto dalla Croce, e dove Noi saremo rappresentati ai piedi del Figlio e della Madre nell'atto di offrire loro la nostra corona e il nostro scettro. Ammoniamo il signor arcivescovo di Parigi, e gli ordiniamo nondimeno che ogni anno, nella festa e nel giorno dell'Assunzione, faccia commemorare la nostra presente dichiarazione nella messa solenne, che sarà detta nella sua chiesa cattedrale, e che dopo i vespri di detto giorno, nella detta chiesa si farà una processione, alla quale parteciperanno tutte le compagnie sovrane e gli organi cittadini, con cerimonie simili a quelle che si osservano nelle processioni generali più solenni, che vogliamo si facciano anche in tutte le chiese; sia parrocchiali che quelle dei monasteri di detta città e sobborgo, e in tutte le città, paesi e villaggi della detta diocesi di Parigi. Esortiamo parimenti gli arcivescovi e i vescovi del nostro regno, e nondimeno ingiungiamo loro di celebrare la stessa solennità nelle loro chiese episcopali, e delle loro diocesi, intendendo che a detta cerimonia siano presenti le corti del Parlamento e altre compagnie sovrane, e i principali ufficiali delle città, e avvertendo tutti i popoli ad avere una particolare devozione verso il Vergine, d'implorare in questo giorno la sua protezione, affinché, sotto una così potente Patrona, il nostro regno sia protetto da tutte le imprese dei nostri nemici, che goda lungamente di buona pace, che Dio vi sia servito e venerato così santamente affinché noi e i nostri sudditi arriviamo felici al fine ultimo per il quale tutti siamo stati creati, poiché tale è il nostro desiderio». Con questo voto, Luigi XIII istituì le processioni del 15 agosto durante le quali i sudditi avrebbero dovuto pregare Dio e la Vergine per i felici successi del re. Ogni chiesa del regno era tenuta, nella misura in cui la chiesa stessa non era già sotto il patronato della Vergine, a dedicare un altare o cappella principale alla Regina del Cielo. Luigi XIII promise infine di costruire un nuovo altare maggiore nella cattedrale di Notre Dame di Parigi, nonché di offrire alla cattedrale un nuovo gruppo scultoreo. LA NASCITA DELL'EREDE AL TRONO (DIEUDONNÉ, CIOÈ “DATO DA DIO”) Intanto, il 5 settembre 1638, nasceva il tanto desiderato figlio, Luigi XIV, il famoso Re Sole, soprannominato Dieudonné, cioè “dato da Dio”, proprio perché dono immeritato del Signore, ottenuto per intercessione della Vergine Maria, in un matrimonio sostanzialmente sterile, che si trascinava da oltre un ventennio. Da quell'anno 1638, ogni 15 agosto fu dedicato al ricordo di quel voto e della consacrazione della Francia e del suo popolo alla Madonna. Luigi XIII non fece in tempo ad adempiere al voto: vale a dire a costruire il nuovo altare maggiore a Notre Dame. Questo compito spettò al figlio, Luigi XIV, sessant'anni dopo. Dal 1708 al 1725, l'architetto Robert de Cotte rimodellò completamente il coro della cattedrale parigina, mascherando i costoloni con archi semicircolari più moderni. Ai lati dell'altare maggiore furono collocate sei statue di angeli in bronzo recanti gli strumenti della Passione di Cristo e quelle dei due re inginocchiati, Luigi XIII in atto di offrire scettro e corona di Guillaume Coustou e quella di Luigi XIV scolpita da Antoine Coysevox. Dietro l'altare maggiore, sotto l'arcata centrale dell'abside, fu collocato il gruppo scultoreo della Pietà, in marmo di Carrara, opera di Nicolas Coustou, che lo realizzò tra il 1714 e il 1715. Queste due statue dei re e quella della Pietà vennero rimosse nel 1793 e ricollocate nella cattedrale solo nel 1815, quelle dei sovrani su nuovi piedistalli completati nel 1816 con lo stemma del re di Francia. Tutto il gruppo scultoreo, pegno del voto del pio re di Francia, sono scampati miracolosamente al terribile incendio della cattedrale del 15 aprile 2019. La consacrazione della Francia e del re furono confermate da Luigi XIV il 25 marzo 1650 e vennero rinnovate in occasione del centenario del voto, nel 1738, dal re Luigi XV. Le campane e le processioni si svolsero ogni anno il 15 agosto sino alla Rivoluzione francese e per l'esattezza sino al 1791 compreso: il 14 agosto 1792, infatti, l'Assemblea legislativa rivoluzionaria abolì la consacrazione della Francia ed il voto; l'anno seguente, il 10 novembre 1793, profanata la cattedrale, essa fu trasformata nel tempio della dea Ragione. Con la caduta di Napoleone e la Restaurazione, il re Luigi XVIII ristabilì la celebrazione del voto nel 1814. Sotto la c.d. Monarchia di Luglio, nell'agosto 1831, il re Luigi Filippo I, figlio della Rivoluzione, abolì definitivamente il voto ed ogni celebrazione, nonostante la ferma e vana protesta di intellettuali cattolici come Lamennais, Lacordaire e Montalembert. Per la verità, già dalla modifica costituzionale del 1830 allorché la religione cattolica cessò di essere religione di Stato, il voto aveva perso forza di legge ed era caduto nel dimenticatoio, lasciando sostanzialmente all'iniziativa locale, popolare o diocesana, la celebrazione della ricorrenza. SANTA GIOVANNA D'ARCO PATRONA DI FRANCIA (DOPO L'ASSUNTA) A
La ridicola festa di san Napoleone al posto dell'Assunta
TESTO DELL'ARTICOLO ➜ https://www.bastabugie.it/it/articoli.php?id=7909 [https://www.bastabugie.it/it/articoli.php?id=7909] LA RIDICOLA FESTA DI SAN NAPOLEONE AL POSTO DELL'ASSUNTA di Francesco Patruno È da pochi giorni trascorsa la solennità dell'Assunzione della Beata Vergine Maria. Anzi, siamo nell'ottava della ricorrenza. Ovviamente, come sempre ogni anno, nell'indifferenza religiosa di coloro che, in questo periodo di ferie estive, sono più intenti a pensare a come trascorrere il Ferragosto, magari in riva al mare, dopo una notte insonne intorno ad un fuoco, tra canti e gozzoviglie varie. Pensando a questo, mi è venuta in mente come la data del 15 agosto abbia segnato la storia della Chiesa e della fede. Basti pensare a Napoleone Bonaparte, che, nato, appunto, un 15 agosto (1769), lungi dal sentirsi onorato per questa singolare e felice coincidenza, tentasse persino di abolire la festa mariana dell'Assunta, per non sentirsi ripetere, proprio nel giorno del suo genetliaco, al Vangelo, il passo lucano della visita di Maria a S. Elisabetta, con il canto del Magnificat nel quale la Vergine fanciulla di Nazaret, echeggiando le parole di Anna, la madre di Samuele, magnifica ed esulta in Dio perché disperde «i superbi nei pensieri del loro cuore», rovescia «i potenti dai troni» ed innalza gli umili. Divenuto imperatore nel 1804, con proprio decreto del 19 febbraio 1806, al fine di consolidare - a fini propagandistici la sua immagine - e sostenuto anche dalle logge massoniche, decise di abolire la festività dell'Assunta nel suo Impero, sostituendola con una festa nazionale dedicata a un improbabile San Napoleone, una figura inventata per l'occasione. Questo presunto santo, il cui vero nome era Neopolo (deformato, appunto, in Napoleone), venne presentato come un anziano martire della fede ed ufficiale romano, morto in prigione il 2 maggio 304 a causa delle torture subite sotto gli imperatori Diocleziano e Massimiano. Tale figura era associata a un gruppo di martiri (Santi Saturnino, Celestino e Germano). La statua di questo santo si trova ancora oggi su una guglia del Duomo di Milano, collocata lì nel 1811 e opera dello scultore Giuseppe Fabris. Così, il 15 agosto, Napoleone avrebbe potuto vedere celebrato il suo compleanno e il suo onomastico con gli onori di una festa nazionale, a misura del suo ego smisurato. Tuttavia, questa ricorrenza durò meno di un decennio. Come ci ricorda la prima lettera di Pietro, «Dio resiste ai superbi, ma dà grazia agli umili» (1 Pt 5,5). Con l'esilio di Napoleone a Sant'Elena, in effetti, la festa nazionale a lui dedicata fu abolita il 16 luglio 1814 da Luigi XVIII. Nel 1852, l'imperatore Napoleone III tentò di ripristinare la festa, ma solo come anniversario della nascita di suo zio, senza il riferimento a San Napoleone. Pure questo tentativo, però, ebbe breve durata. [...]
Kies je abonnement
Tijdelijke aanbieding
Premium
20 uur aan luisterboeken
Podcasts die je alleen op Podimo hoort
Gratis podcasts
Elk moment opzegbaar
2 maanden voor € 1
Daarna € 9,99 / maand
Premium Plus
Onbeperkt luisterboeken
Podcasts die je alleen op Podimo hoort
Gratis podcasts
Elk moment opzegbaar
Probeer 30 dagen gratis
Daarna € 11,99 / maand
2 maanden voor € 1. Daarna € 9,99 / maand. Elk moment opzegbaar.