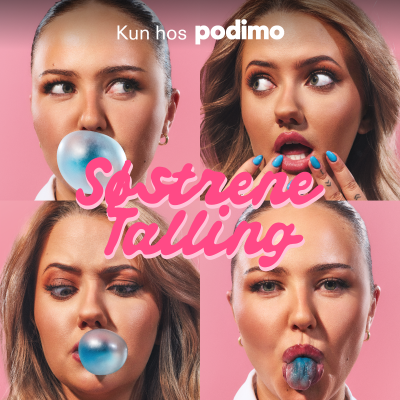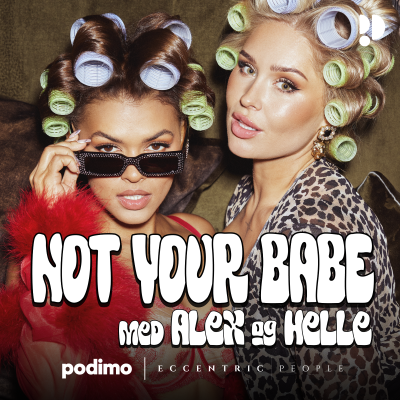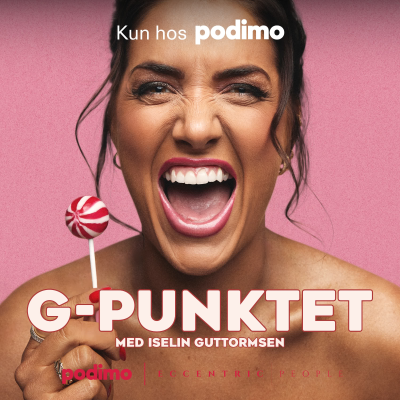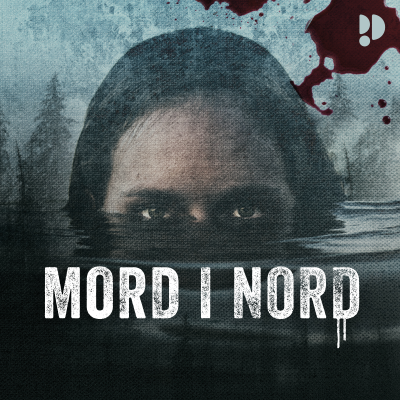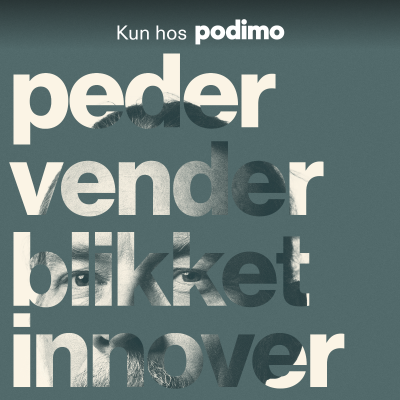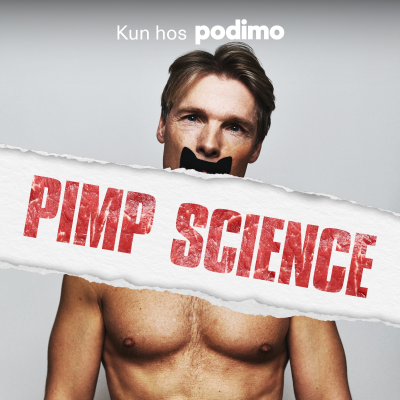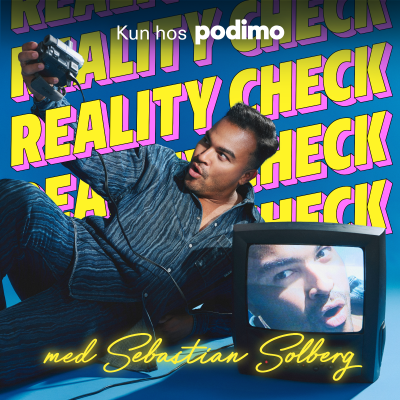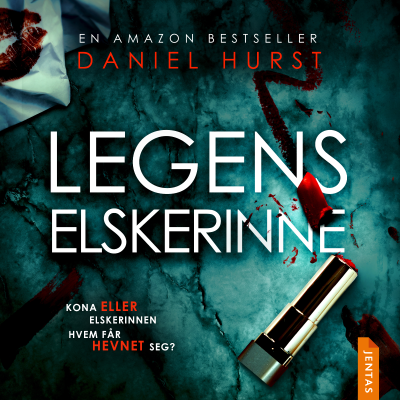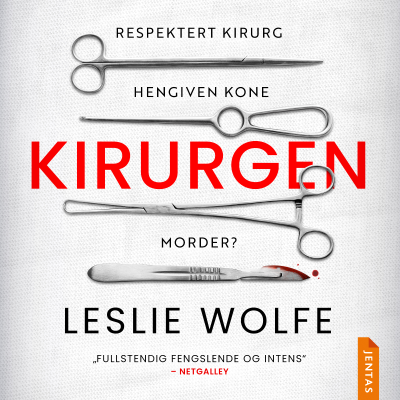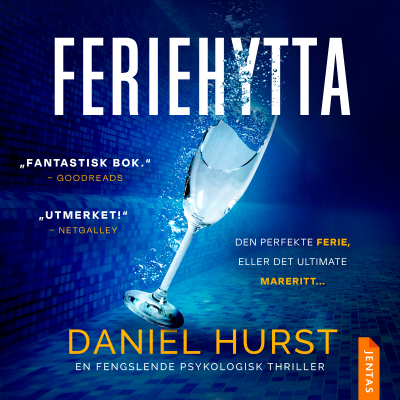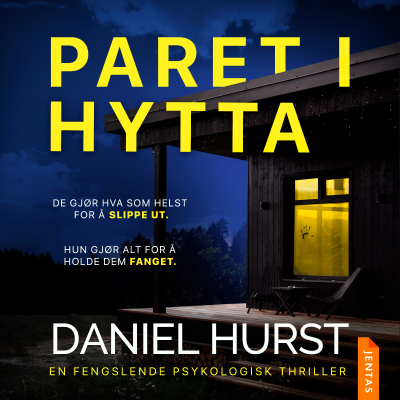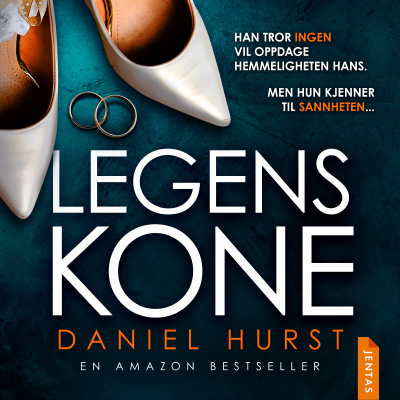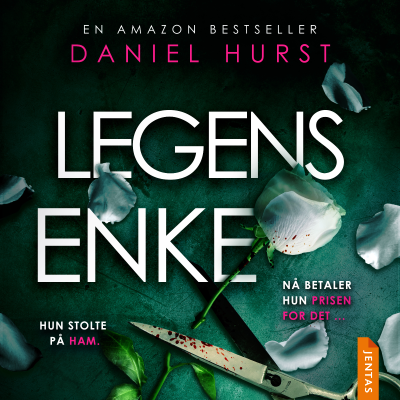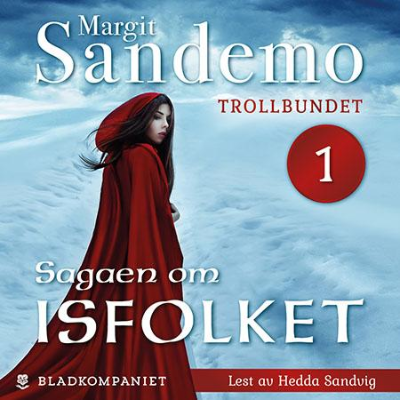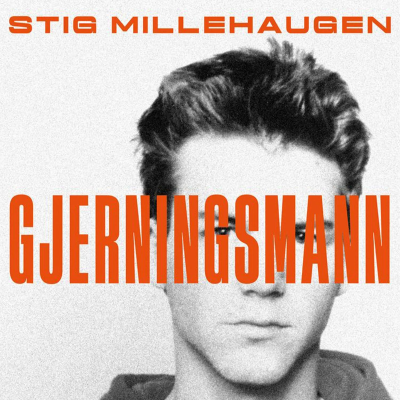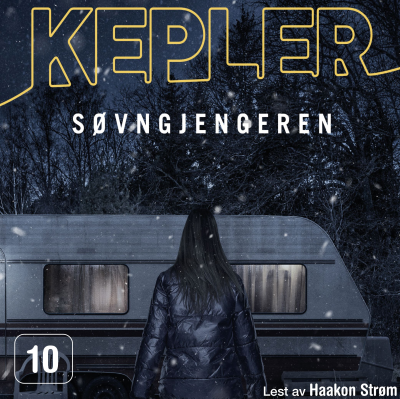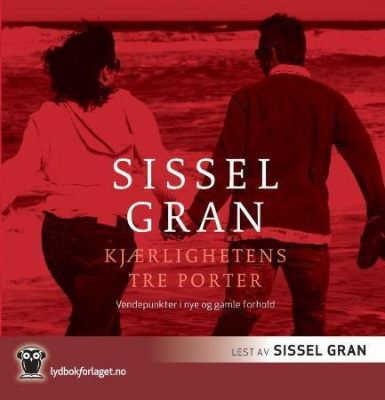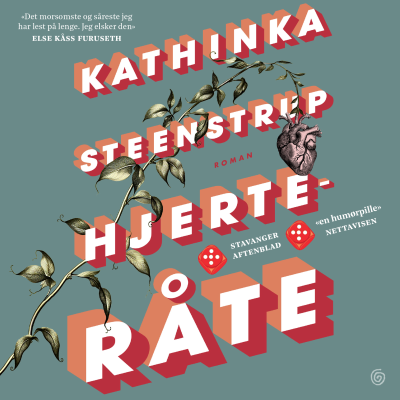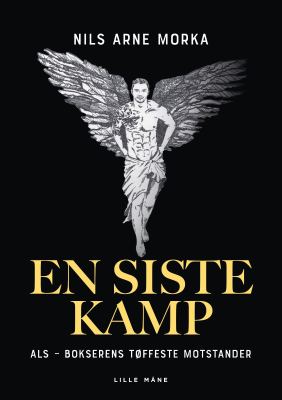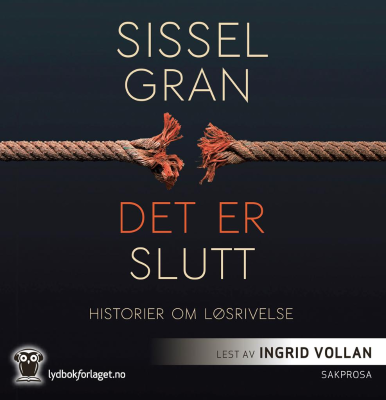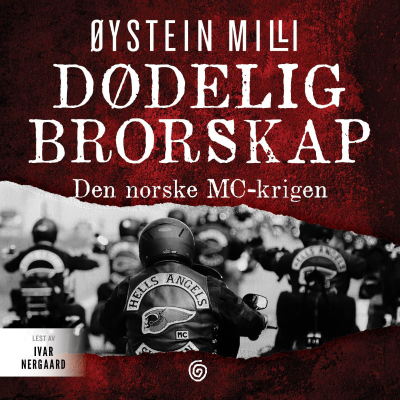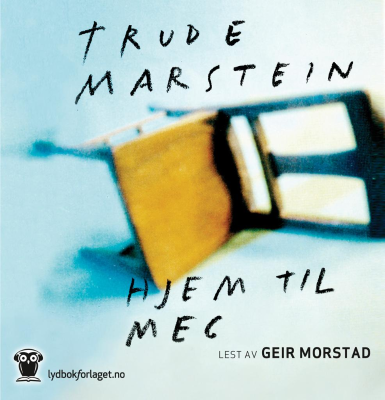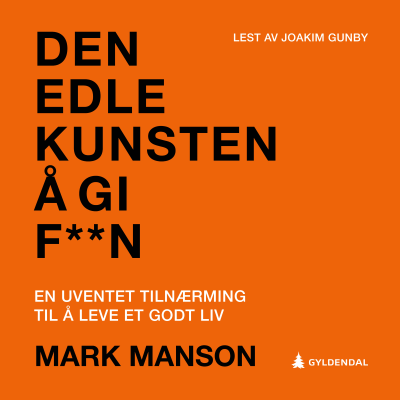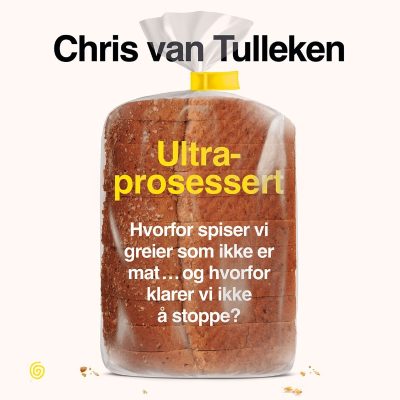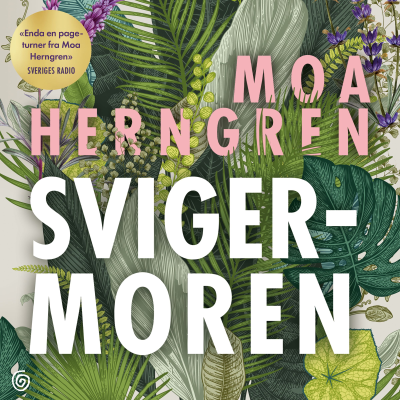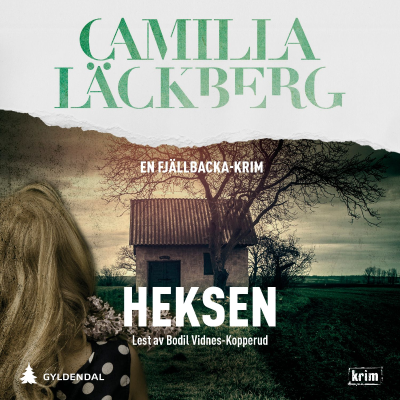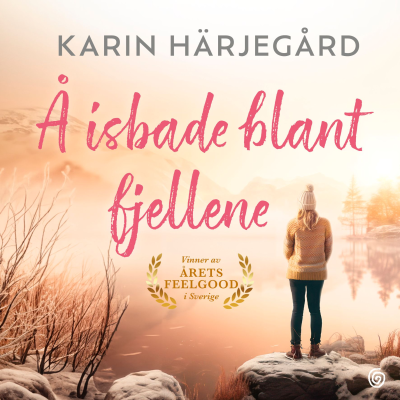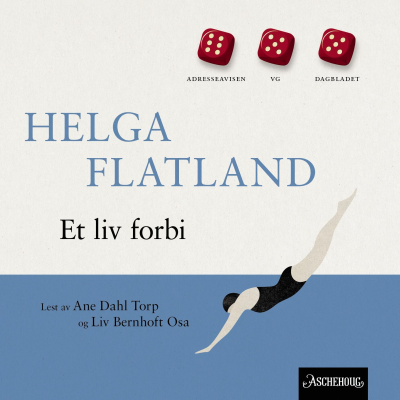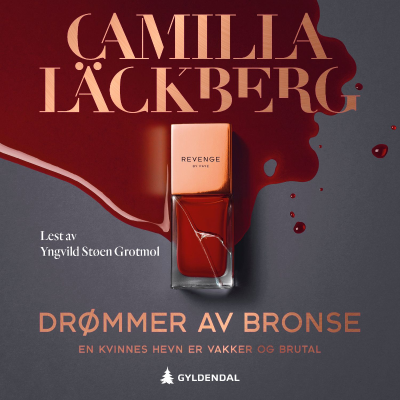Learn Italian with LearnAmo - Impariamo l'italiano insieme!
italiensk
Teknologi og vitenskap
Prøv gratis i 14 dager
99 kr / Måned etter prøveperioden.Avslutt når som helst.
- 20 timer lydbøker i måneden
- Eksklusive podkaster
- Gratis podkaster
Les mer Learn Italian with LearnAmo - Impariamo l'italiano insieme!
Impara l’italiano con LearnAmo – grammatica, esercizi, video e tanto altro ancora!
Alle episoder
578 EpisoderImpara i Pronomi Italiani: la Guida Completa
Hai mai pensato a quanto sarebbe noioso ripetere sempre gli stessi nomi? "Marco ha visto Maria. Marco ha salutato Maria." Ecco perché esistono i pronomi: strumenti linguistici essenziali che rendono il discorso fluido e naturale. In questa guida imparerai a usare tutti i tipi di pronomi italiani con esempi pratici e regole chiare! I PRONOMI ITALIANI: La Guida Completa 1. Pronomi Personali Soggetto I pronomi personali soggetto sostituiscono il nome della persona o della cosa che compie l'azione. Sono fondamentali per identificare chi sta facendo qualcosa e per dare struttura alle nostre frasi. In italiano, questi pronomi si dividono in singolari e plurali, e ognuno ha una funzione specifica nella comunicazione. Forma Singolare Io - prima persona singolare (parlo di me stesso/a). Questo pronome indica colui o colei che sta parlando, il centro della comunicazione. Esempi: Io mangio la pizza, Io studio italiano, Io lavoro a Milano. Tu - seconda persona singolare (parlo con te). Indica la persona con cui si sta parlando direttamente, l'interlocutore immediato. Esempi: Tu studi italiano, Tu parli bene, Tu sei simpatico. Lui/Lei/Egli/Ella/Esso/Essa - terza persona singolare (parlo di qualcun altro). Questi pronomi indicano una persona o cosa di cui si sta parlando, ma che non è presente nella conversazione diretta. Lui si usa per il maschile, Lei per il femminile. Esempi: Lui lavora a Roma, Lei studia medicina, Esso funziona bene (per oggetti). Forma Plurale Noi - prima persona plurale. Indica un gruppo di persone che include chi sta parlando. È il pronome della collettività e dell'inclusione. Esempi: Noi andiamo al cinema, Noi parliamo italiano, Noi abitiamo in Italia. Voi - seconda persona plurale. Indica un gruppo di persone a cui ci si sta rivolgendo direttamente. Esempi: Voi studiate molto, Voi siete italiani, Voi capite tutto. Loro/Essi/Esse - terza persona plurale. Indica un gruppo di persone o cose di cui si sta parlando. Loro è la forma più comune e moderna. Esempi: Loro lavorano insieme, Loro sono amici, Loro vivono a Firenze. Curiosità Importanti In italiano, spesso non usiamo i pronomi soggetto perché il verbo già ci dice chi compie l'azione! Questa è una caratteristica unica dell'italiano rispetto ad altre lingue. Per esempio, possiamo dire "Mangio la pizza" invece di "Io mangio la pizza".La desinenza del verbo (-o) indica chiaramente che il soggetto è "io". Usiamo il pronome soggetto solo quando vogliamo dare enfasi o evitare confusione. Esempi di enfasi: "Io pago il conto!" (sottolineo che sono proprio io a pagare), "Tu devi studiare!" (enfatizzo che è responsabilità tua). ATTENZIONE! Le forme "Egli, ella, essi, esse" sono forme formali e letterarie che appartengono principalmente alla lingua scritta formale e letteraria. Nella lingua parlata quotidiana usiamo sempre "lui, lei, loro". Se vuoi sembrare un libro di poesia dell'Ottocento, usa pure "egli"... ma i tuoi amici italiani ti guarderanno in modo strano! Queste forme si trovano ancora in documenti ufficiali, testi letterari classici e contesti molto formali, ma sono considerate arcaiche nella conversazione moderna. 2. Pronomi Personali Complemento Questi pronomi sostituiscono i complementi nelle frasi: oggetto diretto, oggetto indiretto e altri tipi di complementi. Qui la situazione diventa più complessa e articolata, ma non preoccuparti! Con un po' di pratica e attenzione, diventerà tutto naturale. I pronomi complemento sono essenziali per evitare ripetizioni e rendere il discorso più scorrevole ed elegante. A) Pronomi Diretti (Complemento Oggetto) I pronomi diretti rispondono alla domanda "chi?" o "che cosa?" e sostituiscono il complemento oggetto. Si usano quando l'azione del verbo passa direttamente sull'oggetto, senza bisogno di preposizioni. Forme atone (deboli - si usano prima del verbo coniugato): mi - me (prima persona singolare): Marco mi vede = Marco vede me ti - te (seconda persona singolare): Ti chiamo domani = Chiamo te domani lo - lui/esso (maschile singolare) o "ciò": Lo compro = Compro lui/quello/ciò la - lei/essa (femminile singolare): La vedo = Vedo lei/quella La - Lei (forma di cortesia): La ringrazio, signora = Ringrazio Lei ci - noi (prima persona plurale): Ci invitano = Invitano noi vi - voi (seconda persona plurale): Vi aspetto = Aspetto voi li - loro (maschile plurale): Li conosco = Conosco loro (maschi o gruppo misto) le - loro (femminile plurale): Le compro = Compro loro (cose femminili o donne) Esempi pratici con frasi complete: Vedi Marco? Sì, lo vedo. (lo = Marco) - Invece di ripetere "Sì, vedo Marco" Conosci Maria? Sì, la conosco. (la = Maria) - Invece di "Sì, conosco Maria" Mangi la pasta? Sì, la mangio. (la = la pasta) - Il pronome sostituisce l'intero oggetto Leggete i libri? Sì, li leggiamo. (li = i libri) - Plurale maschile Compri le scarpe? Sì, le compro. (le = le scarpe) - Plurale femminile Trucco da ricordare: "Lo" e "la" diventano "l'" davanti a vocale per ragioni di eufonia (suono piacevole): L'amo (amo lui/lei), L'ho visto (ho visto lui/lei/esso), L'ascolto (ascolto lui/lei). Questo rende la pronuncia più fluida e naturale. I Pronomi Diretti con il Passato Attenzione! Quando usi i pronomi diretti con il passato prossimo (e altri tempi composti), il participio passato deve accordarsi con il pronome in genere e numero. Ma c'è una regola importante da ricordare: Con la 3ª persona singolare (lo, la, l') e plurale (li, le) → l'accordo è OBBLIGATORIO: Hai visto Marco? Sì, l'ho visto. (visto = maschile singolare) Hai visto Maria? Sì, l'ho vista. (vista = femminile singolare) Hai mangiato le mele? Sì, le ho mangiate. (mangiate = femminile plurale) Hai letto i libri? Sì, li ho letti. (letti = maschile plurale) Con la 1ª e 2ª persona singolare e plurale (mi, ti, ci, vi) → l'accordo è FACOLTATIVO (ma sempre corretto se fatto): Marco mi ha chiamato/chiamata. (entrambi corretti!) Maria ci ha visto/visti/viste. (tutte le forme sono corrette!) Ti ho cercato/cercata stamattina. (entrambi corretti!) Curiosità con i Verbi Modali (dovere, potere, volere) Quando usi i pronomi diretti con i verbi modali al passato prossimo, succede una cosa interessante: è il pronome che decide se il participio passato si accorda o no! Se il pronome è PRIMA del verbo modale: Ci hanno voluti vedere. (voluti si accorda con "ci" = noi) Li ho dovuti chiamare. (dovuti si accorda con "li" = loro maschile) L'ho potuta incontrare. (potuta si accorda con "l'" = lei) Se il pronome è DOPO (attaccato all'infinito): Hanno voluto vederci. (NON si accorda: hanno voluto) Ho dovuto chiamarli. (NON si accorda: ho dovuto) B) Pronomi Indiretti (Complemento di Termine) I pronomi indiretti rispondono alla domanda "a chi?" e sostituiscono il complemento di termine. Si usano quando l'azione del verbo è diretta indirettamente verso qualcuno, tipicamente con verbi che richiedono la preposizione "a". Forme atone: mi - a me: Mi telefoni? = Telefoni a me? ti - a te: Ti scrivo = Scrivo a te gli - a lui: Gli parlo = Parlo a lui le - a lei: Le regalo fiori = Regalo fiori a lei Le - a Lei (forma di cortesia): Le chiedo scusa = Chiedo scusa a Lei ci - a noi: Ci scrivono = Scrivono a noi vi - a voi: Vi spiego = Spiego a voi gli/loro - a loro: Gli telefono / Telefono loro = Telefono a loro Esempi dettagliati: Telefoni a Marco? Sì, gli telefono. (gli = a Marco) - Il verbo "telefonare" richiede sempre "a" Scrivi a Maria? Sì, le scrivo. (le = a Maria) - Il verbo "scrivere a qualcuno" Parli ai tuoi genitori? Sì, gli parlo (o: parlo loro). - Terza persona plurale Dai un regalo a me? Sì, ti do un regalo. - Prima persona singolare indiretta Nota importante: "Loro" può essere usato al posto di "gli" per la terza persona plurale, ma presenta una differenza fondamentale di posizione: si mette DOPO il verbo invece che prima. Quindi diciamo: "Parlo loro" invece di "Gli parlo". Però nella lingua moderna e colloquiale, la forma "gli" sta vincendo questa battaglia ed è ormai la più usata, anche se "loro" rimane corretta e viene ancora utilizzata in contesti più formali o letterari. Verbi comuni che usano pronomi indiretti: telefonare, scrivere, parlare, chiedere, rispondere, regalare, dare, mandare, inviare, spedire, raccontare, spiegare, insegnare, prestare, mostrare. C) Pronomi Complemento - Forma Forte (Dopo Tutte le Preposizioni) Oltre alle forme atone (deboli), esistono anche le forme toniche (forti) dei pronomi complemento. Queste si usano DOPO le preposizioni e quando si vuole dare enfasi. Forme toniche: me - me te - te lui/lei/Lei - lui/lei/Lei noi - noi voi - voi loro - loro sé - sé stesso/stessa (forma riflessiva) Quando si usano? 1. DOPO TUTTE LE PREPOSIZIONI (a, di, da, con, per, su, tra, fra, senza...): Vengo con te. (NON: vengo con ti) Parlo di lui. (NON: parlo di lo) Questo regalo è per voi. (NON: questo regalo è per vi) Abito vicino a loro. (NON: abito vicino a gli) Senza di te, mi annoio. Pensano sempre a me. 2. PER DARE ENFASI: Amo te! (più forte di "Ti amo") Ha chiamato me, non te! Cercano proprio voi! 3. DOPO LE COMPARAZIONI (di, come, quanto): Sei più alto di me. Marco è intelligente come te. Lavora quanto noi. FORMA RIFLESSIVA "SÉ": La forma "sé" (con o senza accento, entrambi corretti: "sé" o "se") si usa per la terza persona quando l'azione ricade sul soggetto stesso: Pensa sempre a sé (stesso). Parla da sé. Conta solo su sé (stesso). ESEMPI COMPLETI: Questo libro è per te, non per lui. Viene da noi stasera? Abito lontano da loro. Escono sempre con voi? Pensa solo a sé. D) Pronomi Combinati
Test di VOCABOLARIO Italiano: 15 Parole Fondamentali per il Livello B1
Quanto conosci il vocabolario italiano di livello B1? In questo articolo trovi quindici parole fondamentali, ognuna accompagnata dalla definizione e da spiegazioni utili per capirne il significato e l'uso nella vita quotidiana. Per ogni parola vedrai la prima lettera e una descrizione: prova a indovinare prima di leggere la risposta! Se Conosci Queste Parole, hai un Livello INTERMEDIO Parola 1 – Lettera P Questo è un oggetto piccolo che tieni in tasca o nella borsa e che usi per conservare i soldi e le carte di credito. Che cos'è? [...] La risposta è: portafoglio. Il portafoglio è quell'oggetto dove mettiamo i soldi, le carte di credito, la patente, le tessere… Attenzione: "portafoglio" è una parola composta da "porta" (dal verbo "portare") e "foglio". In origine, serviva per portare i fogli, cioè le banconote. Ricorda che è maschile: il portafoglio. Parola 2 – Lettera S Questa cosa la usi per lavarti le mani. Ha un buon profumo e fa la schiuma. Che cos'è? [...] La risposta è: sapone. Il sapone lo usiamo per lavarci le mani, ma anche per lavare il corpo sotto la doccia. Esiste il sapone solido, quello classico a forma di mattoncino, e il sapone liquido, che esce da un dispenser. Se il sapone ha un buon profumo, possiamo dire che è un sapone profumato. Parola 3 – Lettera R Questo è un verbo. È l'azione di non dimenticare qualcosa, di avere qualcosa nella memoria. Qual è il verbo? [...] La risposta è: ricordare. "Ricordare" significa avere qualcosa nella memoria. Per esempio: "Ricordo ancora la mia prima vacanza al mare". Il contrario è dimenticare. Puoi dire sia "ricordo qualcosa" sia "mi ricordo di qualcosa", con una piccola differenza di sfumatura. Parola 4 – Lettera B Questo è un luogo pubblico dove puoi prendere in prestito i libri gratuitamente. Che cos'è? [...] La risposta è: biblioteca. La biblioteca è un posto dove puoi leggere e prendere in prestito i libri senza pagare. Attenzione a non confondere "biblioteca" con "libreria": la libreria è il negozio dove compri i libri, la biblioteca è dove li prendi in prestito. È un errore molto comune tra gli studenti di italiano. Parola 5 – Lettera B Questo è un documento che ricevi a casa e che devi pagare, per esempio per l'elettricità, il gas o l'acqua. Che cos'è? [...] La risposta è: bolletta. La bolletta è quel foglio (ormai spesso digitale) che ti dice quanto devi pagare per i servizi come la luce, il gas, l'acqua, il telefono… In Italia diciamo spesso "pagare le bollette" per indicare le spese fisse della casa. E quando le bollette sono molto alte, diciamo che sono salate: in italiano, "salato" significa anche "costoso". Parola 6 – Lettera R Questo aggettivo descrive qualcosa o qualcuno che fa molto rumore. Che cos'è? [...] La risposta è: rumoroso. Una cosa rumorosa è una cosa che fa molto rumore. Per esempio: "I miei vicini di casa sono molto rumorosi, fanno sempre feste fino a tardi!". Il contrario di rumoroso è silenzioso. Ricorda: il sostantivo è "rumore", l'aggettivo è "rumoroso". Parola 7 – Lettera S Questo è un verbo. È l'azione di usare le mani o il corpo per muovere qualcosa in avanti. Qual è il verbo? [...] La risposta è: spingere. "Spingere" significa usare forza per muovere qualcosa in avanti. Per esempio, spingiamo un carrello al supermercato o spingiamo una porta per aprirla. Il contrario è tirare. Sulle porte dei negozi in Italia spesso trovi scritto "spingere" o "tirare". Attenzione al participio passato, che è irregolare: spinto. "Ho spinto la porta, ma non si è aperta". Parola 8 – Lettera M Questa è la parte della strada dove camminano i pedoni, le persone a piedi. Che cos'è? [...] La risposta è: marciapiede. Il marciapiede è quella parte rialzata ai lati della strada dove camminiamo noi pedoni. È una parola composta: "marcia" (dal verbo "marciare", cioè camminare) + "piede". Quindi, letteralmente, è il posto dove marciano i piedi. In Italia, camminare sul marciapiede è fondamentale perché le strade spesso sono strette e le macchine passano molto vicine. Parola 9 – Lettera G Questa parola descrive il sentimento negativo che provi quando hai paura di perdere una persona che ami, o quando invidi qualcuno. Che cos'è? [...] La risposta è: gelosia. La gelosia è quel sentimento spiacevole che proviamo quando, per esempio, il nostro partner parla con un'altra persona e noi ci sentiamo minacciati. Ma "gelosia" può anche significare invidia: "Provo gelosia per il suo successo". L'aggettivo è geloso/gelosa: "Sono geloso di te". È un'emozione molto umana, ma attenzione: troppa gelosia non fa bene alle relazioni. Parola 10 – Lettera I Questo aggettivo descrive qualcosa che non serve a niente, che non ha utilità. Che cos'è? [...] La risposta è: inutile. Una cosa inutile è una cosa che non serve. Per esempio: "È inutile chiamarlo, non risponde mai al telefono". Come vedi, in italiano spesso formiamo il contrario aggiungendo il prefisso "in-" davanti all'aggettivo: utile → inutile. Altri esempi: felice → infelice, giusto → ingiusto. Parola 11 – Lettera P Questo è un verbo. È l'azione di riservare in anticipo un tavolo al ristorante, una camera d'albergo o un biglietto. Qual è il verbo? [...] La risposta è: prenotare. "Prenotare" significa riservare qualcosa in anticipo. Puoi prenotare un tavolo al ristorante, un volo, un hotel, un appuntamento dal medico… In Italia, soprattutto nei ristoranti famosi, è molto importante prenotare, altrimenti rischi di non trovare posto. Il sostantivo è prenotazione: "Ho fatto una prenotazione per due persone". Parola 12 – Lettera P Questo aggettivo descrive qualcosa che va molto in basso, che ha molta distanza dalla superficie al fondo. Che cos'è? [...] La risposta è: profondo. Una cosa profonda ha molta distanza tra la superficie e il fondo. Per esempio: "Il mare qui è molto profondo, non tocco!". Ma "profondo" si usa anche in senso figurato: un pensiero profondo, un'amicizia profonda, un libro profondo. Il contrario è superficiale, che si usa sia in senso letterale sia figurato. Parola 13 – Lettera G Questo aggettivo descrive una persona educata, cortese, che tratta gli altri con rispetto. Che cos'è? [...] La risposta è: gentile. Una persona gentile è una persona educata, cortese, che ha buone maniere. Per esempio: "Il cameriere è stato molto gentile con noi". In italiano, quando scrivi un'email formale, spesso inizi con "Gentile Signor/Signora…". Il contrario di gentile può essere scortese o maleducato. Parola 14 – Lettera L Questo è un elettrodomestico che usi per lavare i vestiti. Che cos'è? [...] La risposta è: lavatrice. La lavatrice è l'elettrodomestico che usiamo per lavare i vestiti. "Lavatrice" viene dal verbo "lavare". E l'elettrodomestico che asciuga i vestiti? Si chiama asciugatrice. In Italia, però, molte persone preferiscono ancora stendere i vestiti al sole, sul balcone: è più ecologico e i vestiti profumano di buono. Parola 15 – Lettera N Questo aggettivo descrive qualcosa o qualcuno che non è interessante, che ci annoia. Che cos'è? [...] La risposta è: noioso. Una cosa noiosa è una cosa che ci annoia, che non ci interessa. Per esempio: "Quel film era così noioso che mi sono addormentato!". Puoi usare "noioso" anche per le persone: "Lui è un po' noioso, parla sempre delle stesse cose". Il verbo è annoiare e il sostantivo è noia: "Che noia questa lezione!". Tabella Riepilogativa Delle 15 Parole B1 N°ParolaTipoDefinizioneContrario / Nota1PortafoglioSostantivo (m.)Oggetto per conservare soldi e carteParola composta: porta + foglio2SaponeSostantivo (m.)Si usa per lavarsi, fa la schiumaSolido / Liquido / Profumato3RicordareVerboAvere qualcosa nella memoriaContrario: dimenticare4BibliotecaSostantivo (f.)Luogo dove si prendono libri in prestito≠ Libreria (negozio)5BollettaSostantivo (f.)Documento di pagamento per servizi"Salata" = costosa6RumorosoAggettivoChe fa molto rumoreContrario: silenzioso7SpingereVerboUsare forza per muovere in avantiContrario: tirare – P.P.: spinto8MarciapiedeSostantivo (m.)Parte rialzata della strada per i pedoniParola composta: marcia + piede9GelosiaSostantivo (f.)Sentimento di paura di perdere qualcunoAggettivo: geloso/a10InutileAggettivoChe non serve a nienteContrario: utile (prefisso in-)11PrenotareVerboRiservare qualcosa in anticipoSostantivo: prenotazione12ProfondoAggettivoChe ha molta distanza dalla superficie al fondoContrario: superficiale13GentileAggettivoEducato, corteseContrario: scortese / maleducato14LavatriceSostantivo (f.)Elettrodomestico per lavare i vestitiSimile: asciugatrice15NoiosoAggettivoChe non è interessante, che annoiaVerbo: annoiare – Sost.: noia Domande Frequenti Qual È la Differenza Tra "Biblioteca" e "Libreria"? La biblioteca è un luogo pubblico dove puoi prendere in prestito i libri gratuitamente. La libreria, invece, è un negozio dove si comprano i libri. È uno degli errori più comuni tra gli studenti di italiano, perché in molte altre lingue (come l'inglese "library") la parola somiglia a "libreria" ma ha il significato di "biblioteca". Che Cosa Significa "Bolletta Salata" in Italiano? Quando diciamo che una bolletta è "salata", intendiamo che è molto costosa. In italiano, l'aggettivo "salato" ha un doppio significato: indica sia qualcosa che contiene molto sale, sia qualcosa che ha un prezzo elevato. Per esempio: "Il conto del ristorante era davvero salato!" significa che era molto caro. Come Si Forma il Contrario Degli Aggettivi Con il Prefisso "In-"? In italiano, molti aggettivi formano il contrario aggiungendo il prefisso "in-" davanti alla parola. Ecco alcuni esempi: utile → inutile, felice → infelice, giusto → ingiusto.
Guida alla FORMA PASSIVA: Non Sbagliare Più!
La forma passiva è uno degli argomenti più insidiosi della grammatica italiana, e quasi tutti gli studenti commettono gli stessi errori. In questo articolo scoprirai i 5 errori più comuni con la forma passiva e imparerai come evitarli una volta per tutte. 5 Errori con il Passivo in Italiano Errore N°1: Usare l'Ausiliare AVERE Partiamo dalle basi. Questo è l'errore più grave e, purtroppo, anche molto frequente tra gli studenti di italiano. Alcuni studenti costruiscono frasi come: "La pizza ha mangiata da Marco." Questo è completamente sbagliato. In italiano, l'unico ausiliare per formare il passivo è ESSERE. Sempre. Senza eccezioni. "La pizza è mangiata da Marco." Come Trasformare una Frase Attiva in Passiva Per comprendere meglio il meccanismo della trasformazione, analizziamo un esempio chiaro e dettagliato. Frase Attiva Marco mangia la pizza. Marco = soggetto (chi compie l'azione) mangia = verbo la pizza = complemento oggetto (chi riceve l'azione) Frase Passiva La pizza è mangiata da Marco. La pizza = nuovo soggetto è mangiata = verbo al passivo (essere + participio passato) da Marco = agente (chi compie l'azione) Come vedi, nella trasformazione avvengono tre cambiamenti fondamentali: Il complemento oggetto diventa soggetto Il verbo diventa essere + participio passato Il soggetto originale diventa "agente" e si introduce con la preposizione DA Verbi Transitivi e Intransitivi: Una Distinzione Fondamentale Non tutti i verbi possono avere una forma passiva. Solo i verbi transitivi (cioè quelli che possono avere un complemento oggetto) possono essere trasformati al passivo. "Il libro è letto da Maria." (leggere = transitivo, posso leggere qualcosa) "Il parco è andato da Maria." (andare = intransitivo, non posso "andare qualcosa") Un trucco semplice per riconoscere i verbi transitivi: se nella frase attiva puoi rispondere alla domanda "Che cosa?" dopo il verbo, allora il verbo è transitivo e puoi fare il passivo. Marco mangia... che cosa? → La pizza. Transitivo! Maria va... che cosa? → ??? Intransitivo! Errore N°2: Usare la Preposizione Sbagliata per l'Agente Questo errore è strettamente collegato al primo e riguarda proprio quella parolina che introduce l'agente nella frase passiva. Molti studenti commettono errori come: "La pizza è mangiata per Marco." "La pizza è mangiata di Marco." Ma la preposizione corretta è una sola: DA! "La pizza è mangiata da Marco." Perché Questo Errore È Così Comune? L'origine di questo errore spesso dipende dalla lingua madre dello studente: Chi parla spagnolo spesso usa "per" perché in spagnolo si dice "por" (La pizza es comida por Marco). Chi parla inglese a volte usa "di" perché in inglese si dice "by", che in altri contesti si traduce con "di" (a book by Hemingway = un libro di Hemingway). Ma ricorda: in italiano, per l'agente del passivo, si usa sempre DA. Esempi Corretti con la Preposizione DA Questo quadro è stato dipinto da Caravaggio. La lettera sarà scritta da me. I biscotti sono stati preparati da mia nonna. L'America fu scoperta da Cristoforo Colombo. La Divina Commedia è stata scritta da Dante Alighieri. Errore N°3: Confondere il Passivo Presente con il Passato Questo errore è molto subdolo e dipende da come funziona il passato prossimo in italiano. Guarda questa frase: "La pizza è mangiata." Molti studenti pensano: "Vedo due parole: 'è' + 'mangiata'. Due parole = passato prossimo!" SBAGLIATO! Questa frase è al presente passivo, non al passato! Il segreto è questo: nel passivo, il tempo è determinato SOLO dall'ausiliare ESSERE. Tabella dei Tempi Verbali al Passivo Tempo VerbaleForma PassivaNumero di ParolePresenteLa pizza è mangiata2 parolePassato prossimoLa pizza è stata mangiata3 paroleImperfettoLa pizza era mangiata2 paroleTrapassato prossimoLa pizza era stata mangiata3 parolePassato remotoLa pizza fu mangiata2 paroleTrapassato remotoLa pizza fu stata mangiata3 paroleFuturo sempliceLa pizza sarà mangiata2 paroleFuturo anterioreLa pizza sarà stata mangiata3 parole Come vedi, per il passato prossimo passivo servono tre parole: essere (al presente) + stato/a/i/e + participio passato. La Differenza È Fondamentale La pizza è mangiata = Presente (qualcuno la sta mangiando ora, in generale) La pizza è stata mangiata = Passato prossimo (qualcuno l'ha già mangiata) È una differenza enorme! Confonderle può creare grandi malintesi nella comunicazione. Immagina di essere in un ristorante e dire "La pizza è mangiata" (presente) invece di "La pizza è stata mangiata" (passato): il cameriere potrebbe pensare che qualcuno stia ancora mangiando la pizza, invece di capire che è già finita. Errore N°4: Sostituire Sempre ESSERE con VENIRE Forse hai sentito dire che in italiano si può usare anche il verbo VENIRE per formare il passivo. Ed è vero! La pizza viene mangiata da Marco. Questa frase è perfettamente corretta e significa la stessa cosa di "La pizza è mangiata da Marco." Ma attenzione: c'è una regola importante! La Regola Fondamentale di VENIRE VENIRE si può usare SOLO con i tempi semplici. I tempi semplici sono: presente, imperfetto, passato remoto, futuro semplice, congiuntivo presente, congiuntivo imperfetto, condizionale presente. La pizza viene mangiata. (presente) La pizza veniva mangiata. (imperfetto) La pizza verrà mangiata. (futuro) Ma con i tempi composti? No, non si può! La pizza è venuta mangiata. → SBAGLIATO! La pizza è stata mangiata. → CORRETTO! Tabella Comparativa: ESSERE vs VENIRE TempoCon ESSERECon VENIREPresenteè mangiataviene mangiataImperfettoera mangiataveniva mangiataPassato remotofu mangiatavenne mangiataFuturo semplicesarà mangiataverrà mangiataPassato prossimoè stata mangiataè venuta mangiataTrapassato prossimoera stata mangiataera venuta mangiataFuturo anterioresarà stata mangiatasarà venuta mangiata Perché Esiste l'Alternativa con VENIRE? Spesso si usa "venire" per dare un senso più dinamico all'azione, per sottolineare che qualcosa sta accadendo in quel momento. Inoltre, "venire" può aiutare a evitare ambiguità: la frase "La porta è chiusa" potrebbe significare sia "La porta viene chiusa (da qualcuno)" sia "La porta è in stato di chiusura". Usando "La porta viene chiusa" si elimina l'ambiguità e si indica chiaramente un'azione in corso. Errore N°5: Non Riconoscere le Strutture Passive "Nascoste" Ed eccoci all'ultimo errore, forse il più insidioso di tutti. Esistono alcune strutture che sono passive... ma non sembrano passive! Molti studenti non le riconoscono e quindi non le capiscono. Vediamone tre molto comuni. 1) ANDARE + Participio Passato "Questo lavoro va fatto entro domani." Che cosa significa? Significa che questo lavoro deve essere fatto entro domani. È un obbligo, una necessità. La struttura andare + participio passato ha un significato passivo con valore di dovere/necessità. Altri Esempi con ANDARE + Participio Le regole vanno rispettate. = Le regole devono essere rispettate. Questo documento va firmato. = Questo documento deve essere firmato. I compiti vanno consegnati venerdì. = I compiti devono essere consegnati venerdì. La carne va cotta bene. = La carne deve essere cotta bene. Questi medicinali vanno presi a stomaco pieno. = Questi medicinali devono essere presi a stomaco pieno. Attenzione: anche "andare" segue la regola del punto 4! Si usa solo nei tempi semplici. Il lavoro va fatto. (presente) Il lavoro andava fatto. (imperfetto) Il lavoro è andato fatto. → Sbagliato! 2) Participio Passato da Solo (Participio Assoluto) "Fatte queste premesse, possiamo continuare." Questa struttura si chiama participio assoluto e ha valore passivo. Significa: "Dopo che queste premesse sono state fatte..." Il participio, posto all'inizio della frase, indica un'azione già compiuta che precede l'azione principale. Altri Esempi di Participio Assoluto Letto il libro, ho capito tutto. = Dopo che il libro è stato letto (da me)... Finiti i compiti, sono uscito. = Dopo che i compiti sono stati finiti... Considerati tutti i fattori, la decisione è stata difficile. = Dopo che tutti i fattori sono stati considerati... Superato l'esame, ho festeggiato. = Dopo che l'esame è stato superato... Aperta la porta, entrò nella stanza. = Dopo che la porta fu aperta... Questa struttura è molto usata nella lingua scritta e formale, ma si sente anche nel parlato. Se non la riconosci, rischi di non capire il significato della frase. 3) Il "SI" Passivante "In Italia si mangia molta pasta." Questa frase non significa che qualcuno mangia se stesso (quello sarebbe riflessivo!). Significa: "In Italia molta pasta è mangiata" / "In Italia la gente mangia molta pasta." È il famoso SI passivante: si usa quando non vogliamo o non possiamo specificare chi compie l'azione. Come Riconoscere il SI Passivante Il verbo concorda con il sostantivo che segue: Si mangia molta pasta (pasta = singolare → verbo singolare) Si mangiano molti spaghetti (spaghetti = plurale → verbo plurale) Si legge un libro / Si leggono molti libri Si parla l'italiano / Si parlano molte lingue Esempi Comuni del SI Passivante Il si passivante è estremamente comune in italiano. Lo sentirai e leggerai ovunque: Qui si parla italiano. (= L'italiano è parlato qui) Non si accettano carte di credito. (= Le carte di credito non sono accettate) Come si dice "hello" in italiano? (= Come è detto "hello" in italiano?) In questo negozio si vendono prodotti biologici. (= Prodotti biologici sono venduti) Affittasi appartamento. (= Un appartamento viene affittato - forma molto comune negli annunci) Se non riconosci questa struttura,
Impara l’Italiano con le Serie TV: STRANGER THINGS
Hai mai guardato una serie TV in italiano e pensato: "Ma che cosa ha detto?!" Le serie TV sono un'ottima risorsa per imparare espressioni autentiche. Con questo articolo imparerai 12 espressioni italiane colloquiali usate nel doppiaggio italiano di Stranger Things, quelle che sentirai spesso nelle conversazioni quotidiane. 12 Espressioni Italiane da Stranger Things 1. Banale Nullità Contesto nella Serie Nell'episodio 1 della stagione 2, Jonathan Byers cerca di consolare suo fratello minore Will, che è stato preso in giro a scuola con il soprannome "Zombie Boy". Per rassicurarlo e fargli capire che essere diversi non è un difetto, Jonathan gli dice: "Va bene? E preferisco essere amico di Zombie Boy che di una banale nullità." Che Cosa Significa? Questa espressione è composta da due parole: Banale, che indica qualcosa di ordinario, scontato, senza originalità, e Nullità, che descrive una persona insignificante, priva di valore o personalità. Quindi una "banale nullità" è una persona completamente priva di interesse, noiosa, che non ha nulla di speciale. Si tratta di un insulto piuttosto forte. Esempi d'Uso "Non voglio passare il sabato sera con quelle banali nullità. Andiamo da un'altra parte." "Il nuovo collega? Una banale nullità. Non ha mai un'opinione su niente." Nota Linguistica In italiano usiamo spesso "nullità" per indicare una persona senza valore. Puoi anche dire semplicemente "Sei una nullità!" se vuoi essere più diretto. 2. Essere in Gambissima Contesto nella Serie Nell'episodio 6 della stagione 2, Lucas Sinclair cerca di conquistare Max Mayfield, la ragazza appena trasferita a Hawkins che gli piace molto. Mentre i due sono da soli, Lucas vuole farle capire quanto la ammiri e, guardandola negli occhi, le dice: "E tu sei forte, sei diversa e sei in gambissima." Che Cosa Significa? L'espressione di base è "essere in gamba", che significa essere una persona capace, intelligente, sveglia, che sa fare le cose bene. Qui abbiamo "in gambissima", con il superlativo assoluto -issima, che rende l'espressione ancora più forte: significa essere molto in gamba, davvero eccezionale. Esempi d'Uso "La mia nuova avvocata è in gambissima: ha risolto tutto in una settimana." "Tuo figlio è proprio in gamba. A soli 10 anni parla già tre lingue." Attenzione "Essere in gamba" si usa solo per le persone, non per le cose. Quindi è corretto dire "Marco è in gamba", ma non puoi dire "Questo computer è in gamba". 3. Essere Fuori Strada Contesto nella Serie Nell'episodio 4 della stagione 4, ritroviamo sempre Max Mayfield, ormai parte integrante del gruppo. Quando qualcuno le propone di trascorrere il tempo nello scantinato di Mike Wheeler, lei rifiuta categoricamente con il suo carattere diretto: "Se credi che passerò quello che sembra essere il mio ultimo giorno di vita nel lurido scantinato di Mike Wheeler, sei fuori strada." Che Cosa Significa? Letteralmente, "fuori strada" indica qualcuno che ha sbagliato direzione, che non è sulla strada giusta. In senso figurato significa sbagliarsi completamente, avere un'idea totalmente sbagliata della situazione. Esempi d'Uso "Pensi che io abbia rubato i tuoi soldi? Sei completamente fuori strada." "Se credi che ti presterò la macchina dopo quello che è successo, sei fuori strada." Espressioni Simili EspressioneRegistroSei fuori!Più colloquialeTi sbagli di grosso!StandardNon ci siamo proprio!Colloquiale 4. Che Cosa Cavolo...? Contesto nella Serie Nell'episodio 3 della stagione 2, ancora una volta Max Mayfield si fa notare per il suo temperamento schietto. Quando assiste a qualcosa di inaspettato che la lascia sorpresa e irritata, reagisce esclamando: "Ma che cosa cavolo fai?" Che Cosa Significa? "Cavolo" è un eufemismo, cioè una parola più gentile che sostituisce una parola volgare. Si usa per esprimere sorpresa, rabbia o frustrazione in modo meno offensivo. Esempi d'Uso "Che cavolo stai dicendo?" "Ma dove cavolo sei andato?" "Cavolo! Ho dimenticato le chiavi." Altri Eufemismi Italiani EufemismoUsoAccidenti!Esclamazione genericaMannaggia!Espressione di frustrazionePorca miseria!Esprime rabbia Nota Linguistica Il cavolo è un ortaggio molto presente nelle espressioni italiane: "Non me ne importa un cavolo", "Fatti i cavoli tuoi", "Col cavolo!" (per dire "assolutamente no"). 5. Rompiscatole Testa Calda Contesto nella Serie Nell'episodio 3 della stagione 5, Jim Hopper, lo sceriffo di Hawkins e padre adottivo di Eleven, si confronta con la ragazza dopo l'ennesimo momento di tensione. Con il suo tipico tono burbero ma affettuoso, esasperato dal suo comportamento impulsivo, le dice: "Sei una rompiscatole testa calda, lo sai, sì?" Che Cosa Significa? Qui abbiamo due espressioni insieme: Rompiscatole indica una persona fastidiosa, che dà sempre problemi, che non ti lascia in pace (è anche una versione più educata di un'altra espressione più volgare). Testa calda descrive una persona impulsiva, che agisce senza pensare, che si arrabbia facilmente. Una "rompiscatole testa calda" è quindi qualcuno che è sia fastidioso sia impulsivo. Esempi d'Uso "Mio fratello è un vero rompiscatole: mi chiama dieci volte al giorno." "Non fare il testa calda. Pensa prima di parlare." 6. Non Me Ne Fotte Niente Contesto nella Serie Nell'episodio 3 della stagione 5, quando la sorella viene a chiamarlo per la cena, Derek risponde con tono calmo e annoiato: "Non me ne fotte niente della mamma." Attenzione: Espressione Volgare Che Cosa Significa? Significa "non mi importa per niente", ma in modo molto forte e maleducato. Il verbo "fottere" è volgare, quindi questa espressione si usa solo in contesti molto informali, tra amici stretti, o quando sei molto arrabbiato. Alternative Più Educate EspressioneLivello di FormalitàNon me ne importa nienteNeutroNon mi interessaFormaleNon me ne può fregar di menoColloquiale (ancora un po' forte)Me ne infischioColloquiale ma non volgare Consiglio Se stai imparando l'italiano, è importante capire queste espressioni quando le senti, ma fai attenzione a usarle: potrebbero offendere qualcuno se usate nel contesto sbagliato. 7. Annaspare Contesto nella Serie Nell'episodio 1 della stagione 4, conosciamo Eddie Munson, il carismatico leader dell'Hellfire Club, il club di Dungeons & Dragons della Hawkins High School. Mentre parla con i suoi compagni nella mensa della scuola, ammette con ironia: "Io annaspo a fatica verso una D nei compiti della O'Donnell." Che Cosa Significa? Annaspare ha due significati: nel significato letterale, indica il muovere le braccia e le gambe in modo disordinato, come quando stai per affogare in acqua; nel significato figurato, significa fare molta fatica, trovarsi in grande difficoltà, non riuscire a portare avanti qualcosa. Nel contesto della serie, Eddie sta dicendo che fa molta fatica a scuola, che a stento riesce a prendere voti sufficienti. Esempi d'Uso "Sto annaspando con questo progetto: è troppo difficile." "Dopo aver perso il lavoro, annaspa per arrivare a fine mese." "Nuota malissimo: quando entra in acqua, annaspa come un pesce fuor d'acqua." 8. Rimanere di Stucco Contesto nella Serie Nell'episodio 1 della stagione 5, Robin Buckley, l'ironica e sarcastica amica di Steve Harrington, racconta via radio un episodio che l'ha completamente spiazzata. Descrivendo la sua reazione di totale stupore, dice riferendosi a se stessa: "[...] ...la sottoscritta è rimasta di stucco." Che Cosa Significa? Rimanere di stucco significa rimanere molto sorpresi, sbalorditi, senza parole. È come rimanere immobili dalla sorpresa, come se fossi diventato una statua. Lo "stucco" è un materiale usato in edilizia, che diventa duro quando si asciuga. L'immagine è quella di una persona che rimane ferma, rigida, come se fosse fatta di stucco. Esempi d'Uso "Quando ho saputo che Marco si sposava, sono rimasto di stucco." "La notizia mi ha lasciato di stucco: non me l'aspettavo proprio." Espressioni Simili EspressioneImmagine EvocataRimanere di sassoPietrificato come un sassoRimanere a bocca apertaStupore fisico visibileRestare senza paroleIncapacità di parlareRimanere di saleRiferimento biblico alla moglie di Lot 9. Dare un Taglio / Diamoci un Taglio Contesto nella Serie Nell'episodio 7 della stagione 5, Murray Bauman, l'eccentrico ex giornalista e investigatore privato che ha aiutato il gruppo in diverse occasioni, interviene durante una discussione che si sta prolungando troppo. Con il suo modo diretto e pragmatico, cerca di riportare l'altra persona alla realtà dicendo: "[...] quindi diamoci un taglio netto." Che Cosa Significa? Dare un taglio significa smettere di fare qualcosa, finirla, piantarla. Si usa quando vuoi dire a qualcuno (o a te stesso) di smettere con un comportamento. "Taglio netto" aggiunge enfasi: significa smettere completamente, senza mezze misure. Esempi d'Uso "Dacci un taglio con queste lamentele." "Ho dato un taglio ai dolci: voglio dimagrire." "Ragazzi, diamoci un taglio e torniamo a lavorare." Attenzione Non confondere "dacci un taglio" (smettere) con "farsi un taglio" (che significa farsi i capelli o tagliarsi accidentalmente). 10. Secchione / Secchiona Contesto nella Serie Nell'episodio 6 della stagione 3, Dustin Henderson, il membro più nerd del gruppo, si rivolge ad Erica durante una conversazione. Quando lei fa un commento che lui trova troppo ottimista o poco realistico, la prende in giro dicendole: "Pensavo che fossi più realista, secchiona." Che Cosa Significa? Un secchione (o una secchiona) è uno studente che studia moltissimo, che passa tutto il tempo sui libri.
La Verità Nascosta Dietro i LUOGHI COMUNI sull’Italiano
Quante volte hai sentito dire che l'italiano è la lingua più bella del mondo? O che è particolarmente difficile, con un vocabolario più ricco delle altre? In questo articolo scoprirai la verità su alcune caratteristiche dell'italiano che molti considerano esclusive, distinguendo i fatti reali dai semplici luoghi comuni. L'Italiano È Davvero la Lingua più Bella del Mondo? Il Mito del Congiuntivo Cos'È il Congiuntivo? Il congiuntivo è un modo verbale che si usa per esprimere dubbi, desideri, opinioni e possibilità. Si tratta di una forma verbale che permette di comunicare sfumature di significato che l'indicativo non è in grado di trasmettere. Ecco alcuni esempi pratici del suo utilizzo: Tipo di espressioneEsempio con congiuntivoSignificatoSperanza"Spero che tu stia bene"Esprime un desiderioOpinione"Credo che lui sia simpatico"Indica un'opinione personaleDesiderio"Vorrei che tu venissi con me"Comunica un desiderioDubbio"Non sono sicuro che abbia capito"Esprime incertezza Il Rapporto degli Italiani con il Congiuntivo Gli italiani hanno un rapporto particolare con questo modo verbale. L'errore nel congiuntivo viene spesso percepito come segno di scarsa cultura o mancanza di istruzione. Ma il congiuntivo è davvero una caratteristica esclusiva dell'italiano? La Verità sul Congiuntivo nelle Altre Lingue Assolutamente no. Se conosci un'altra lingua romanza — spagnolo, francese, portoghese, rumeno — sai bene che anche queste lingue hanno un congiuntivo. Un aspetto interessante è che solo gli italiani attribuiscono tanta importanza a questo modo verbale. Gli spagnoli e i francesi hanno un atteggiamento più rilassato sull'argomento. E l'inglese? Molti italiani pensano che l'inglese non abbia il congiuntivo, considerandolo per questo una lingua "inferiore". Ma non è corretto. Anche l'inglese conserva tracce del congiuntivo. Per esempio, nella frase "I suggest that he be present at the meeting", quel "be" è un congiuntivo. Si tratta del cosiddetto subjunctive mood, che esiste tuttora nella grammatica inglese, anche se viene usato meno frequentemente rispetto all'italiano. Quindi no, il congiuntivo non è qualcosa di esclusivamente italiano. Le Consonanti Doppie: una Caratteristica Italiana? Cosa Sono le Consonanti Doppie o "Geminate" Passiamo ora a un'altra caratteristica che sembra tipicamente italiana: le consonanti doppie, chiamate anche "geminate" nel linguaggio tecnico della linguistica. Si tratta di consonanti che vengono pronunciate più a lungo, con più intensità. In italiano si scrivono raddoppiando la lettera: "mamma", "pizza", "cappuccino", "bellissimo". L'italiano usa effettivamente le doppie in modo molto più esteso rispetto ad altre lingue. Considera una frase come: "Quell'uomo basso con gli occhiali era simpaticissimo: ogni volta che passavo mi salutava con affetto." Le consonanti doppie presenti sono numerose, e questo è tipico dell'italiano, che fa un uso pervasivo di questo fenomeno fonetico. Le Consonanti Doppie nelle Altre Lingue Tuttavia, le consonanti doppie non esistono solo in italiano. Ecco alcuni esempi da altre lingue: LinguaEsempi di parole con doppieNoteSpagnolo"innovación", "perenne"La doppia si può pronunciareCatalano"novel·la" (romanzo), "cel·la" (cella)Consonanti geminate evidentiFranceseAlcuni casi foneticiDoppie a livello foneticoGiapponese"kitte" (francobollo), "nippon"Consonanti geminate distintiveFinlandese"kukka" (fiore), "kissa" (gatto)Uso sistematico delle doppie La Differenza Fondamentale: il Valore Fonologico La differenza sostanziale è questa: in italiano le doppie hanno un valore fonologico, cioè cambiano il significato delle parole. La distinzione tra consonante semplice e doppia è quindi essenziale per la comunicazione. Consonante sempliceConsonante doppiaDifferenza di significatopalapallaStrumento vs oggetto sfericocarocarroAggettivo vs veicolonotenotteAppunti vs periodo buiocasacassaAbitazione vs contenitoresetesetteBisogno di bere vs numerofatofattoDestino vs participio passato In altre lingue, invece, le doppie sono spesso solo fonetiche, senza impatto sul significato. L'uso estensivo delle consonanti doppie con valore distintivo è quindi una caratteristica abbastanza peculiare dell'italiano, almeno tra le grandi lingue romanze. Alcune Strutture Grammaticali Particolari dell'Italiano Esistono altre caratteristiche interessanti che rendono l'italiano diverso dalle altre lingue. Analizziamole nel dettaglio. Gli Articoli Determinativi Maschili Gli articoli determinativi sono quelle piccole parole che si mettono davanti ai nomi per indicare qualcosa di specifico: "il", "lo", "la", "i", "gli", "le". L'italiano presenta una particolarità: possiede due forme per l'articolo determinativo maschile singolare: "il" e "lo". E al plurale: "i" e "gli". L'uso dipende dalla lettera con cui inizia la parola successiva: Articolo singolareArticolo pluraleQuando si usaEsempiiliDavanti a consonante sempliceil libro → i librilogliDavanti a s+consonante, z, gn, ps, x, ylo zaino → gli zainilogliDavanti a gruppi consonantici complessilo psicologo → gli psicologil'gliDavanti a vocale (maschile)l'amico → gli amici Questa doppia forma è abbastanza particolare rispetto ad altre lingue romanze, dove generalmente esiste un solo articolo determinativo maschile (come "el" in spagnolo o "le" in francese). Il Congiuntivo con le Opinioni Affermative Un altro aspetto interessante: in italiano si usa il congiuntivo dopo espressioni come "penso che", "credo che", "mi sembra che". Per esempio: "Penso che Marco sia intelligente." In spagnolo, francese e portoghese, invece, si usa l'indicativo in questi casi: LinguaFraseModo verbaleItaliano"Penso che Marco sia intelligente"CongiuntivoSpagnolo"Creo que Marco es inteligente"IndicativoFrancese"Je pense que Marco est intelligent"IndicativoPortoghese"Acho que Marco é inteligente"Indicativo Questo è un uso del congiuntivo che risulta tipico dell'italiano. L'Italiano Non Usa Sempre "Più" Congiuntivo Questo non significa che l'italiano sia "più raffinato". Esistono altri casi in cui le altre lingue usano il congiuntivo e l'italiano no: LinguaFraseModo verbaleSpagnolo"Cuando llegues, llámame"CongiuntivoItaliano"Quando arrivi, chiamami"Indicativo L'uso del congiuntivo non è quindi uniforme tra le lingue: ogni lingua ha le sue regole specifiche. Il Mito del Lessico Più Ricco Cos'È il Lessico? L'italiano ha davvero più parole delle altre lingue? Prima di rispondere, è necessario chiarire cosa si intende per "lessico". Il lessico è semplicemente l'insieme di tutte le parole di una lingua, includendo sostantivi, verbi, aggettivi, avverbi, preposizioni e tutte le altre categorie grammaticali. Il Problema del Conteggio delle Parole Molti italiani credono che l'italiano abbia un vocabolario più ricco, specialmente rispetto all'inglese. Tuttavia, contare le parole di una lingua è molto complicato. Prima di tutto: cos'è una parola? "Mangio", "mangi", "mangiamo"... sono tre parole diverse o forme della stessa parola? I pronomi come "lo", "la", "gli" sono parole indipendenti? Queste domande dimostrano quanto sia difficile stabilire criteri oggettivi per il conteggio. I Numeri a Confronto LinguaStima del numero di paroleNoteItaliano215.000 - 270.000Secondo alcuni calcoliInglese~170.000Secondo alcuni dizionari Questi numeri variano considerevolmente a seconda del dizionario utilizzato e dei criteri di conteggio. Non esiste un metodo universalmente accettato per determinare la "ricchezza" lessicale di una lingua. Il Vocabolario di Base: Quello che Conta Davvero In realtà, quello che conta davvero è il vocabolario di base, cioè le parole usate nella vita quotidiana: Tipo di vocabolarioNumero di parolePercentuale d'usoVocabolario di base italiano~6.500 parole98% delle frasi quotidianeVocabolario di un madrelingua medio15.000 - 20.000 paroleVariabile Il vocabolario conosciuto da un madrelingua dipende molto dal livello di istruzione e dalle abitudini di lettura. L'Italiano È Davvero una Lingua Difficile? Molti sostengono che l'italiano sia una lingua "difficile". Ma rispetto a cosa? Confronto con le Lingue Romanze Se si paragona l'italiano alle altre lingue romanze, la complessità grammaticale risulta molto simile: LinguaCaratteristiche grammaticaliSpagnoloStessi tempi e modi verbali dell'italianoFranceseMorfologia altrettanto complessaPortoghesePiù tempi verbali dell'italiano Confronto con Altre Lingue del Mondo Guardando alle lingue del mondo, ne esistono molte con grammatiche decisamente più complesse: Tipo di linguaEsempiCaratteristica complessaLingue con i casiRusso, tedesco, finlandeseDeclinazione dei sostantivi (fino a 15 casi nel finlandese)Lingue tonaliCinese mandarino, vietnamita, thaiIl tono cambia il significato della parolaLingue agglutinantiTurco, ungherese, giapponeseParole molto lunghe composte da molti suffissiLingue polisinteticheInuktitut, mohawkUna sola parola può esprimere un'intera frase Rispetto a queste lingue, l'italiano appare in realtà relativamente accessibile. Quindi, l'Italiano È Speciale? La risposta corretta è: sì e no. Perché "No": i Miti da Sfatare No, l'italiano non ha caratteristiche uniche che lo rendono "superiore" alle altre lingue: MitoRealtàIl congiuntivo esiste solo in italianoEsiste in molte lingue romanze e anche in ingleseLe consonanti doppie sono esclusiveEsistono anche in altre lingue (catalano, finlandese, giapponese...)L'italiano ha il vocabolario più riccoNon è possibile stabilirlo oggettivamenteL'italiano è la lingua più difficileEsistono lingue con grammatiche molto più complesse Perché "Sì": Ogni Lingua È Unica Sì, l'italiano è speciale, come ogni lingua è speciale.
Velg abonnementet ditt
Premium
20 timer lydbøker
Eksklusive podkaster
Gratis podkaster
Avslutt når som helst
Prøv gratis i 14 dager
Deretter 99 kr / måned
Premium Plus
100 timer lydbøker
Eksklusive podkaster
Gratis podkaster
Avslutt når som helst
Prøv gratis i 14 dager
Deretter 169 kr / måned
Prøv gratis i 14 dager. 99 kr / Måned etter prøveperioden. Avslutt når som helst.